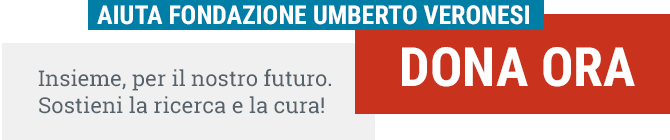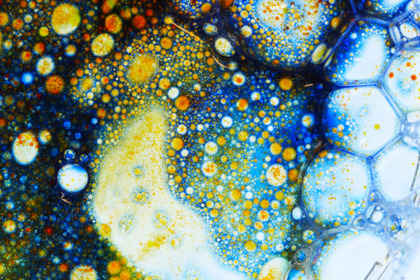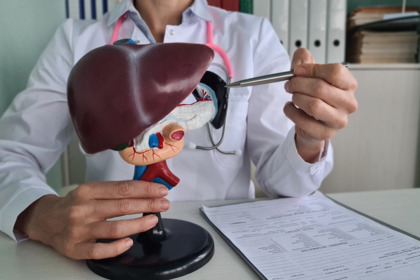Potrebbe esserci una mutazione alla base della capacità di questo tumore di diventare invisibile di fronte alle nostre difese: è l’ipotesi che sta valutando la ricercatrice Elena Ciaglia

I risultati terapeutici finora ottenuti per il glioblastoma multiforme, uno dei tumori al cervello più aggressivi, sono apprezzabili ma ancora troppo modesti: la prospettiva di sopravvivenza a partire dalla diagnosi si attesta a circa un anno. La ricerca in questo campo deve quindi fare ancora molti passi avanti. Una caratteristica di tutti i tumori è la loro capacità di rendersi invisibili alla sorveglianza continua del sistema immunitario: spesso i responsabili di questa strategia messa in campo dai tumori sono i cosiddetti oncogeni, geni mutati responsabili dello sviluppo e crescita tumorale. Il gene Egfr (recettore per il fattore di crescita epiteliale) è uno degli oncogeni più noti per il glioblastoma: viene infatti analizzato nei pazienti per valutare diagnosi e prognosi e per prevedere quale sarà la risposta alla terapia. Con un finanziamento erogato dalla Fondazione Umberto Veronesi, la biotecnologa Elena Ciaglia dell’Università di Salerno punta a capire in che modo le mutazioni sul gene EGFR possano contribuire a sottrarre i glioblastomi al controllo da parte del sistema immunitario, e nello specifico da parte dei linfociti NK (Natural Killers), cellule capaci di riconoscere e uccidere le cellule cancerose.
Elena, ci daresti qualche dettaglio in più sul tuo progetto di ricerca?
«I linfociti NK sono cellule importantissime del sistema immunitario: il loro ruolo nel distruggere le cellule di diversi tipi di tumore, in primis il melanoma, è ormai chiaro. È invece meno chiaro quale sia il loro coinvolgimento nel contrastare il glioblastoma. L’obiettivo del mio lavoro è proprio quello di conoscere qual è il grado di funzionalità delle cellule NK che penetrano il glioblastoma e di quelle circolanti nel sangue, come si relazionano con il microambiente tumorale, e i meccanismi tramite cui le mutazioni su EGFR possono influenzare la loro generazione e la loro attività. Lo studio verrà compiuto su modelli cellulari in vitro e su resezioni chirurgiche di pazienti».
Quali potrebbero quindi essere le future prospettive per la salute dei pazienti?
«Grazie a questo studio potremo raggiungere una migliore comprensione del glioblastoma e dei suoi intrinseci meccanismi di fuga dalle risposte immunitarie: un passo in più verso l’identificazione di nuovi possibili bersagli terapeutici».
Sei mai stata all’estero a fare ricerca?
«Sì: ho fatto parte di un dottorato di ricerca internazionale in “Oncologia ed endocrinologia molecolare”, e pertanto ero tenuta a spendere alcuni mesi del mio percorso formativo all’estero. Ho quindi lavorato presso il National Institutes of Allergy and Infectious Diseases di Bethesda, negli Stati Uniti, dove ho appreso per la prima volta le tecniche per studiare la funzionalità delle cellule NK. Da allora, a distanza di dieci anni, la loro linea di ricerca continua ad affascinarmi ed emozionarmi, ed è una delle tematiche che seguo più attivamente».
Cosa ricordi di questa esperienza?
«Non nascondo che il solo pensiero di dovermi spostare da sola per la prima volta all’estero, e per di più catapultata subito in USA, mi spaventava terribilmente. Ma è bastato metter piede nel laboratorio per sentirmi nel mio mondo anche a distanza di chilometri. Era bello avere tutto a disposizione (dai reagenti alle apparecchiature più sofisticate) e poter quindi programmare esperimenti e realizzarli subito, lo stesso giorno».
Cosa avresti fatto se non avessi fatto la ricercatrice?
«Da piccola sognavo di fare l’archeologa: già allora ero affascinata dalla scoperta di frammenti di verità. Oggi che sono ricercatrice non riesco a vedermi in altri panni: non ho mai voluto pensare ad un piano B, neanche nei mesi bui in cui sono stata senza compenso, senza una guida scientifica o senza valide prospettive per il futuro. Continuavo sempre a ripetermi che sarebbe arrivata la giusta ricompensa per gli sforzi fatti: si tratta solo di tempo, perché il lavoro ripaga sempre».
Una figura che ti ha ispirato nella tua vita personale o professionale.
«Se dicessi Umberto Veronesi, mi credereste? Non lo dico per retorica, davvero: l’ho sempre ammirato, per me è stato un esempio di vita che ho seguito sin da piccola. È per questo motivo che il finanziamento della Fondazione Umberto Veronesi mi rende piena di orgoglio e mi dà quella marcia in più per crederci, sempre».
Come pensi che si possano approcciare i complottisti e i diversi gruppi contrari alle istanze della comunità scientifica?
«Secondo me l’unica strada è organizzare sempre più campagne di sensibilizzazione e comunicazione scientifica: scendere tra loro, trasmettere in parole semplici l’importanza della ricerca facendo esempi pratici, diventare per loro un nuovo modello di riferimento. “Quando i bambini guarderanno i grandi scienziati come guardano i grandi cantanti e attori, la civiltà passerà al livello successivo”, ha affermato il fisico statunitense Brian Greene. È per questo che ho sposato subito l’iniziativa “Ricercatore in classe” di Fondazione Veronesi».
E tu, hai famiglia?
«Sì: un bimbo di otto anni e un marito che mi sta accanto e mi appoggia dall’età di 15 anni».
E se un giorno tuo figlio ti dicesse che vuole fare il ricercatore?
«Diciamo che in qualche modo già lo fa. Dall’età di 6 anni in estate frequenta il campo scuola della nostra struttura, e al termine della sua giornata di giochi ed attività mi raggiunge in lab: ama definirsi “il mio assistente” e sogna di diventare un giorno il mio “laureando preferito”. In classe con gli amici ha allestito un vero e proprio laboratorio (dopo aver saccheggiato il mio). Se è quello che lo fa sentire pienamente realizzato e che non gli fa chiudere occhio la notte prima di un esperimento importante, continuerò sempre ad appoggiarlo e spronarlo. Sarebbe bellissimo condividere un lavoro (e quindi condividere una passione) con il proprio figlio».
Cosa fai nel tempo libero?
«Nella pausa pranzo corro, a giorni alterni, alla piscina del nostro campus: mi ricarica e mi dà il giusto entusiasmo per concludere la giornata. La sera torno in famiglia e sono tutta per loro: non posso e non voglio sottrarre loro ulteriore tempo».
Un ricordo a te caro di quando eri bambina.
«Mio nonno che mi accompagnava ogni giorno a scuola mano nella mano. Noi che insieme ripetevamo le tabelline, la storia o altri argomenti del giorno, per tutto il tragitto. Davanti alla scuola mi salutava con un bacino e mi ripeteva ogni giorno: ce la farai».
Con quale personaggio ti piacerebbe andare a cena una sera, e di cosa parlereste?
«Giocando di fantasia, da appassionata e studiosa di immunoterapia, andrei indietro nel tempo e inviterei a cena l’immunologo Ralph Steinmann, scomparso nel 2011 per un tumore al pancreas tre giorni prima che gli assegnassero il Nobel. Gli chiederei come avrebbe accolto la notizia e a chi avrebbe dedicato un riconoscimento così prestigioso».

Agnese Collino
Biologa molecolare. Nata a Udine nel 1984. Laureata in Biologia Molecolare e Cellulare all'Università di Bologna, PhD in Oncologia Molecolare alla Scuola Europea di Medicina Molecolare (SEMM) di Milano, Master in Giornalismo e Comunicazione Istituzionale della Scienza all'Università di Ferrara. Ha lavorato nove anni nella ricerca sul cancro e dal 2013 si occupa di divulgazione scientifica