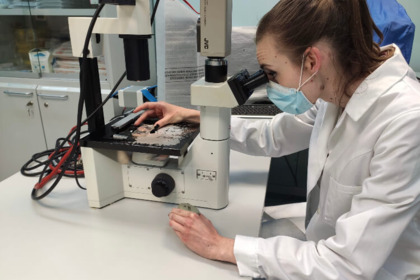Le donne in carcere hanno un rischio di epatite C doppio rispetto agli uomini e 14 volte più alto di chi sta "fuori". Malattie infettive e salute mentale le urgenze. Gli esperti chiedono regole uniformi

Le persone in carcere sono una popolazione osservata speciale, anche per quanto riguarda la salute. Gli ultimi dati confermano fra i problemi principali la salute mentale e le malattie infettive. Le donne, in particolare, che sono una minoranza nelle carceri, presentano però tassi particolarmente alti di alcune patologie, prima fra tutte l’epatite C.
MALATTIE INFETTIVE: COVID MENO IMPATTANTE DEL PREVISTO
Nelle carceri italiane transitano ogni anno circa 100.000 persone e vi risiedono oltre 53.500 persone (dati al 31 dicembre 2020), di cui 2.250 circa sono donne. Le condizioni di vita e il contesto rendono complessa la tutela della salute, che - vale la pena ricordarlo - resta un diritto fondamentale anche aldilà delle porte di un penitenziario. In occasione del suo ultimo congresso nazionale, la SIMSPe, Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, ha presentato il quadro della situazione. L’infezione da Sars-CoV-2 e la Covid-19 hanno colpito meno duramente di quanto si temesse ma, come ha sottolineato Luciano Lucanìa, presidente SIMSPe, sono emerse profonde disparità e problemi strutturali già noti: «l’importante penetrazione del virus in alcuni Istituti e la quasi totale assenza in altri dimostra chiaramente la mancanza di linee organizzative minimamente omogenee nel sistema. Troppo spesso si finisce per lasciare l'organizzazione dei 190 Istituti Penitenziari italiani alla buona volontà di chi vi opera».
L’EPATITE C: IN CARCERE RISCHIO MOLTIPLICATO
Resta invece alto il livello d’attenzione per l’infezione da HCV. Uno studio ancora in corso sta facendo emergere dati preoccupanti nella popolazione carceraria femminile L’indagine, realizzata dal network ROSE - Rete dOnne SimspE, sta raccogliendo dati sulle infezioni da HIV e da epatite C nelle donne detenute in diverse carceri italiane. I dati preliminari riguardano 5 istituti penitenziari di 4 diverse regioni, che rappresentavano il 10% delle detenute. Dati numericamente contenuti e ancora preliminari, ma come ha evidenziato la Rete sono i più completi mai raccolti sul tema. Nell’ultimo anno sono state coinvolte 156 detenute, per oltre la metà italiane, 41 anni l’età media, alcune (il 18 per cento) facente uso di stupefacenti per via endovenosa. Elena Rastrelli, responsabile del progetto, riassume: «Abbiamo riscontrato dati eloquenti: la siero prevalenza di HCV riguardava il 20,5%, una cifra leggermente superiore rispetto alla prevalenza riportata nella letteratura internazionale più recente, nonché di due volte superiore rispetto al 10,4% del genere maschile». Dati coerenti con quelli del Ministero che, sottolinea la dottoressa Rastrelli, indicano per le donne in carcere un rischio doppio rispetto agli uomini e di 14 volte superiore rispetto alla popolazione generale di contrarre l’epatite C.
SERVONO INTERVENTI MIRATI
In aggiunta, più della metà delle donne HCV positive avevano un’infezione attiva, un tasso di coinfezioni (da HIV e da epatite B) molto più alto che negli uomini e la maggior parte non ne era consapevole. Urgente, concludono quindi gli specialisti SIMSPe, intervenire in modo mirato sulla popolazione femminile incarcerata: sono relativamente poche e oggi disponiamo di terapie eradicanti efficaci per l’epatite C, in grado di prevenire problemi gravi e duraturi, fra cui cirrosi e tumori del fegato. Va anche detto che la pandemia ha segnato la campagna per l'eradicazione dell'epatite C su tutto il territorio nazionale. Nel mese di luglio gli esperti della SIMIT (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali) avevano avvisato che il rallentamento è stato tale da spingere l'Italia fuori della tabella di marcia dell'OMS per arrivare ad eliminare l'epatite C nel 2030.
PROBLEMI STRUTTURALI
Come avevamo già avuto modo di raccontare sul Magazine, la gestione della salute nella popolazione penitenziaria è complicata non solo dal contesto (la privazione di libertà, le condizioni delle detenute e dei detenuti, più spesso della media affetti da tossicodipendenza o disturbi psichiatrici, in situazioni di degrado, scarsa istruzione, solitudine). Ma anche dall’organizzazione strutturale della sanità carceraria, che dal 2008 è passata dall’amministrazione giudiziaria al Ministero della Salute, ovvero alle Regioni. Ha spiegato il professor Sergio Babudieri, già presidente SIMSPe e direttore dell’Unità Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera di Sassari: «Per garantire alle persone detenute una qualità dell'assistenza sanitaria pari ai liberi cittadini, il prezzo pagato è stato la perdita dell'unicità del sistema. Nelle carceri italiane manca uniformità anche solo nei contratti del personale medico, infermieristico e tecnico. Il sistema è altamente disomogeneo anche all’interno delle stesse regioni. Il Decreto aveva istituito degli osservatori regionali per la tutela della salute in carcere, ma solo poche regioni particolarmente virtuose come Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia si sono organizzate; manca un approccio sistematico». Servirebbe una legge quadro che indichi a tutte le Regioni i requisiti minimi da garantire, i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) utilizzati per la gestione della sanità nazionale. A tutto ciò, va aggiunta la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, a cui si è risposto in maniera frammentaria, un ulteriore “buco” nella tutela della salute delle persone in carcere.
Sostieni la ricerca, sostieni la vita. Dona ora per la ricerca contro i tumori femminili

Donatella Barus
Giornalista professionista, dirige dal 2014 il Magazine della Fondazione Umberto Veronesi. E’ laureata in Scienze della Comunicazione, ha un Master in comunicazione. Dal 2003 al 2010 ha lavorato alla realizzazione e redazione di Sportello cancro (Corriere della Sera e Fondazione Veronesi). Ha scritto insieme a Roberto Boffi il manuale “Spegnila!” (BUR Rizzoli), dedicato a chi vuole smettere di fumare.