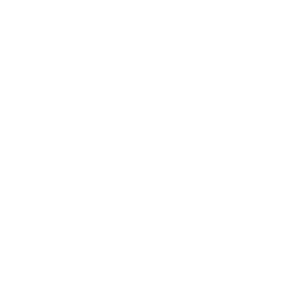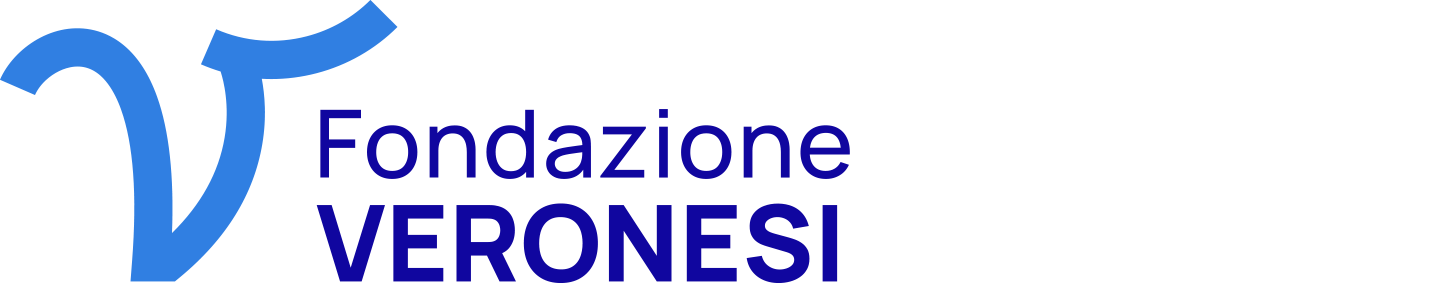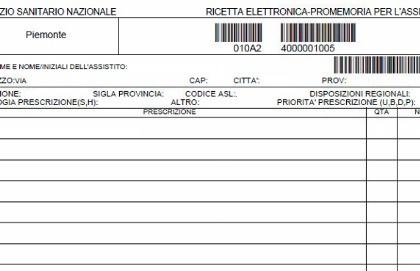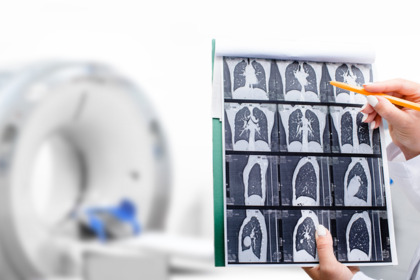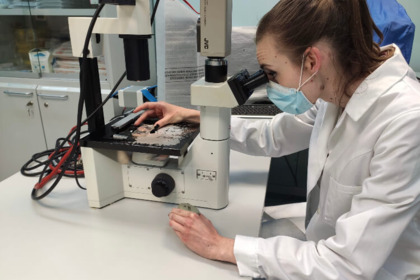Crisi dei medici di famiglia. All'appello mancano oltre 5.500 professionisti e il futuro rischia di peggiorare

In Italia mancano più di 5.500 medici di famiglia. Un numero destinato a crescere nei prossimi anni a causa dei pensionamenti e del calo di interesse da parte dei giovani medici verso questa professione. È quanto emerge dall’ultimo report della Fondazione GIMBE, che fotografa una delle crisi più gravi del nostro Sistema Sanitario Nazionale. Eppure, quella del medico di famiglia – o medico di medicina generale, come si dice in termini tecnici – è una figura centrale nella gestione della nostra salute: accompagna le persone lungo tutte le fasi della vita, cura le patologie acute e croniche, prescrive esami e terapie, e ha un ruolo chiave nella prevenzione e nella diagnosi.
LA SITUAZIONE IN ITALIA
Il medico di Medicina Generale, così si chiama in termini tecnici, è dunque un compagno di strada imprescindibile, nato insieme al nostro Sistema Sanitario Nazionale nel 1978. Peccato si tratti di una categoria professionale preziosa e a rischio estinzione. Dati alla mano, quelli emersi dall’ultimo report della Fondazione GIMBE che fotografa la situazione al 2023, mancano oltre 5.500 medici di famiglia nel nostro Paese. A fronte di migliaia di pensionamenti, il numero di giovani medici che scelgono questa professione continua a diminuire, mentre la popolazione diventa sempre più anziana: nel 2023 gli over 65 erano oltre 14,2 milioni, di cui più della metà affetti da due o più malattie croniche. I medici di medicina generale attivi in Italia nel 2023 erano 37.260, ossia 4.749 in meno rispetto al 2019 e «con l’alta probabilità che il numero sia ulteriormente calato», puntualizza Stefano Celotto, medico di famiglia del Friuli Venezia Giulia e componente della giunta esecutiva nazionale della SIMG (Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie). «Le regioni maggiormente in difficoltà sono la Provincia autonoma di Bolzano, il Veneto, la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia, ossia le zone d’Italia in cui il numero di pazienti per medico è più elevato. Anche alcune regioni del centro e del sud, come il Lazio, la Campania e la Sicilia, attualmente in una situazione migliore, dovranno affrontare a breve il pensionamento di numerosi medici» spiega l'esperto.
LA FIGURA DEL MEDICO DI FAMIGLIA
«La formazione prevede la laurea in medicina e chirurgia della durata di sei anni e un ulteriore percorso di formazione specifica in Medicina Generale, in vigore dal 1991. I medici che si sono laureati prima del 1994, invece, possono continuare a esercitare la professione senza aver conseguito la specializzazione. Non è obbligatorio aver completato la formazione specifica anche per medici di famiglia che svolgono ruoli temporanei, come incarichi provvisori e sostituzioni di medici in malattia, in maternità o in ferie. La scelta del medico, da parte del cittadino, avviene tramite gli Uffici delle Aziende Sanitarie locali che comunicano i nominativi dei medici con posti disponibili presenti nel Comune di residenza. Sarà poi il singolo a scegliere. Molte regioni e aziende sanitarie hanno sviluppato metodi “smart” per la scelta, tramite il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico o la farmacia comunale di riferimento. Il numero massimo di assistiti per ogni medico è 1.500, che possono diventare anche 1.800 in situazioni di carenza di personale, come sta avvenendo soprattutto nel nord Italia e addirittura fino a 2.000 nella Provincia autonoma di Bolzano. C’è sempre inoltre la possibilità di tenere insieme il nucleo familiare e, a questo scopo, il numero di pazienti assegnati al singolo medico può aumentare da 1.500 a 1.575» osserva Celotto.
QUANDO IL MEDICO NON C'È
«Qualora non sia presente nel proprio Comune si cercano medici nel territorio limitrofo o, in extrema ratio, le Aziende sanitarie possono concordare con i Medici di Famiglia per una “soluzione tampone”: l’accesso ad ambulatori in cui gravitano medici diversi che mettono a disposizione un monte ore per garantire la copertura assistenziale. Ovviamente si tratta di opzioni che dovrebbero essere momentanee perché in questo modo manca un punto di riferimento costante per il paziente, ne viene meno la continuità, fondamentale in generale e, in particolare, in situazioni complesse, come in presenza di malattie croniche o oncologiche. È auspicabile, in queste situazioni, che maggiore sia la presa in carico da parte dei reparti ospedalieri. Il pronto soccorso e la guardia medica restano invece punti di riferimento rispettivamente in caso di urgenze e durante il fine settimana e le ore serali e notturne» spiega l'esperto.
IL CARICO DI LAVORO
La premessa è che il massimale di 1.500 assistiti è superato da oltre la metà dei Medici di Medicina Generale in 10 Regioni: Liguria (50,7%), Friuli Venezia Giulia (52,4%), Piemonte (54,1%), Marche (55,5%), Provincia autonoma di Trento (56,1%), Emilia-Romagna (57,6%), Campania (58,8%), Sardegna (60,6%), Valle d’Aosta (61,1%) e Provincia autonoma di Bolzano (65,1%). La percentuale sale oltre i due terzi in Veneto (68,7%) e sfiora i tre quarti in Lombardia (74%). Il livello di sovraccarico riduce ovviamente il tempo da dedicare al singolo paziente. Rischiano di farne le spese, non solo la qualità dell’assistenza, ma il prezioso dialogo che rende speciale e insostituibile il rapporto con il proprio medico di famiglia. «Per un dottore che assiste 1.500 pazienti -aggiunge Celotto- 80 sono, in media, i pazienti con cui si ha un contatto quotidiano o in maniera indiretta, tramite mail, messaggi, oppure attraverso telefonate e visite a domicilio e in studio. Il tempo che si dedica loro è estremamente variabile: dai pochi istanti della compilazione di una ricetta a un dialogo lungo e complesso per i pazienti a cui comunicare una nuova diagnosi o con patologie gravi in corso. In media, un medico di famiglia dedica all’ambulatorio 4 o 5 ore al giorno. Il resto è un lavoro molto articolato e che prevede impegni diversificati. Si passa dalla burocrazia al monitoraggio dei pazienti cronici che spesso necessitano di controlli attivi perché trascurano cure ed esami; dall’attenzione agli screening oncologici alla proposta e somministrazione di vaccini, dal confronto con altri operatori sanitari all’assistenza domiciliare. Il tempo del dialogo resta poi l’aspetto fondamentale e imprescindibile per costruire un legame di fiducia e prendere contatto con la fragilità dei pazienti. Molti vivono da soli a causa della disgregazione delle famiglie e della nuova composizione del tessuto sociale e questa solitudine ha un impatto anche sulla salute e la gestione delle cure. Importante, qualora ci sia, il rapporto con il caregiver, cioè con colui che si prende cura della quotidianità del paziente cronico».
IL RUOLO DEL PEDIATRA
La figura del pediatra di famiglia, istituita nel 1979, costituisce un unicum in Europa ed è dunque un privilegio per chi vive in Italia. «Nel nostro Paese a ogni bambino dalla nascita viene garantito il pediatra per poter accedere a tutti i servizi e prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Essere seguiti da un pediatra, invece che da un medico dell’adulto, è obbligatorio fino ai 6 anni. Tra i 6 e 14 anni i genitori possono, invece, scegliere tra pediatra e medico di famiglia. Al compimento dei 14 anni, in caso di patologie croniche o situazioni di handicap, si può richiedere alla Azienda Sanitaria di continuare ad essere seguiti dal proprio pediatra fino all’età di 16 anni. Ovviamente le competenze specialistiche del pediatra costituiscono un enorme vantaggio per la cura dei più piccoli» spiega l'esperto. Secondo i dati più recenti disponibili, sempre quelli del 2023, i pediatri di famiglia sono 6.681 e anche in questo caso ne mancano almeno 827, soprattutto in Lombardia, Piemonte e Veneto. A seguire, a causa dei pensionamenti, la situazione peggiorerà anche nel Lazio, in Molise, Puglia e Umbria. Entro il 2026 oltre 1.700 pediatri andranno in pensione. Dunque, una situazione per molti versi analoga a quella dei medici per gli adulti.
LE PROSPETTIVE FUTURE
Se tutti i medici di famiglia andassero in pensione a 70 anni e tutte le borse di studio finanziate tra il 2021 e il 2024 fossero assegnate e completate, nel 2027 le nuove leve coprirebbero i pensionamenti attesi e le carenze rilevate nel 2023. Questa la teoria. «Si tratta, infatti, in realtà di un quadro poco realistico -puntualizza l'esperto- perché sempre più medici si ritirano prima dei 70 anni e, soprattutto, sta aumentando il divario tra borse finanziate e iscritti che completano il ciclo formativo. Nel frattempo la professione è diventata sempre meno attrattiva per i giovani, che non solo abbandonano in itinere il corso di formazione, ma sempre più spesso non partecipano nemmeno al bando. Le ragioni sono varie, ma la principale riguarda la mancanza del riconoscimento del ruolo e delle competenze specifiche del medico di famiglia da parte delle istituzioni, a partire dall’ambito universitario che non prevede spesso nemmeno un insegnamento dedicato durante il corso di laurea. A questo si sommano il carico lavorativo in continuo aumento, l’insicurezza riguardo al futuro in relazione all’organizzazione della Sanità e la difficoltà ad accedere alla libera professione, maggiore rispetto ad esempio a quella di un cardiologo, di un dermatologo o di un ortopedico. Anche la mancanza degli infermieri costituisce un grosso problema perché la loro presenza è fondamentale per l’assistenza territoriale dei malati cronici e degli anziani e costituisce una risorsa imprescindibile per i medici di famiglia e per tutta la comunità. Si tratta quindi di uno scenario molto complesso che richiede una riforma generale, a partire da un ripensamento dell’assistenza, valutando modelli già presenti, soprattutto nel nord Europa, come il cohousing. Vivere insieme in una società sempre più sola e frammentaria aiuta a gestire meglio le cure e anche a prevenire le malattie. Le relazioni sociali, non solo sono fondamentali per stare meglio e numerosi studi scientifici lo confermano, ma anche il supporto medico diventa, in questo modo, più semplice ed efficace».