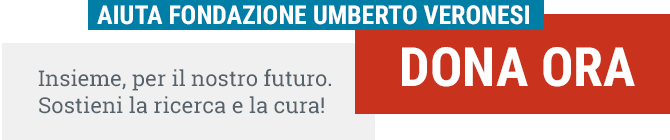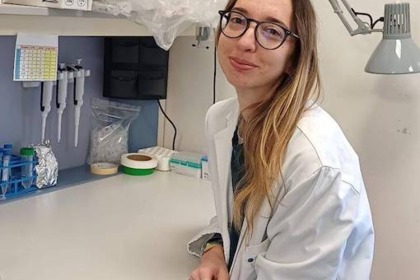Secondo due ricerche pubblicate sul «New England Journal of Medicine», le pazienti operate in laparoscopia (o col Robot) hanno una probabilità più alta di morire nei 4 anni successivi
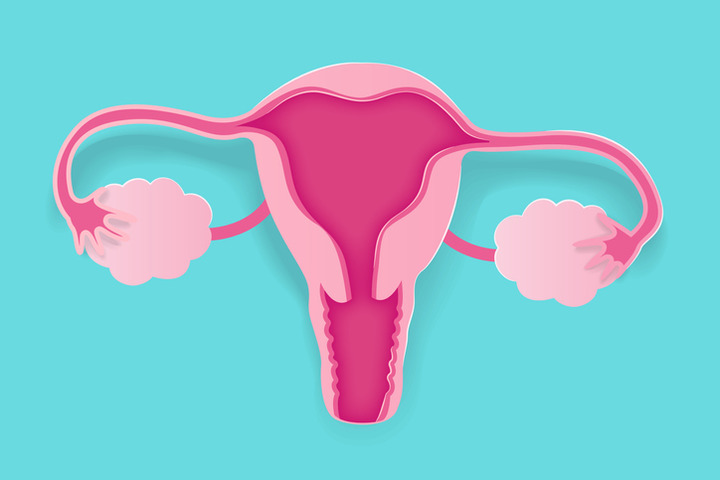
La tendenza ad abbandonare la chirurgia tradizionale per lasciare spazio alla laparoscopia o alla chirurgia robotica fa registrare una battuta d'arresto: almeno in ambito ginecologico. Nel trattamento del tumore della cervice uterina, che ogni anno in Italia colpisce circa 2.200 donne, l'intervento a cielo aperto sembra essere la scelta preferibile. Andando a misurare l'impatto sulla sopravvivenza delle donne colpite da un tumore del collo dell'utero in stadio iniziale, il beneficio dell'isterectomia radicale «open» (con la rimozione dei linfonodi regionali e del sentinella) è infatti superiore a quello garantito dalla chirurgia mininvasiva.
Per la prostata meglio la chirurgia robotica o quella tradizionale?
VECCHIO BATTE NUOVO
Vecchio batte nuovo, con un punteggio schiacciante. Si potrebbero riassumere così le conclusioni di uno studio prospettico, pubblicato sul New England Journal of Medicine, condotto con lo scopo di comparare l'efficacia delle diverse procedure chirurgiche, mininvasiva laproscopica o robotica e tradizionale. Nei tumori operabili in stadio iniziale, lo standard riconosciuto dalla comunità scientifica, ancora oggi, è rappresentato dall'isterectomia ad addome aperto. Un intervento più invasivo per le donne, ma che, misurando la loro sopravvivenza nel tempo, garantisce risultati migliori. Questo è quanto dimostrato dai ricercatori coordinati da Pedro Tomas Ramirez, responsabile dell'unità di chirurgia minivasiva dell’MD Anderson Cancer Center di Houston (Texas) e da Andreas Obermair, direttore del centro di ricerca sui tumori ginecologici dell'Università del Queensland di Brisbane (Australia), che hanno suddiviso un campione di 631 donne (individuate in 33 centri in tutto il mondo) a cui era già stato diagnosticato un tumore del collo dell'utero in stadio 1 (iniziale: limitato alla cervice, senza invasione della vagina o delle strutture pelviche circostanti) per assegnarle ai due possibili trattamenti: chirurgia tradizionale o mininvasiva (prevalentemente laparoscopica, con una minoranza di casi trattati col Robot Da Vinci). Osservando le pazienti a quattro anni e mezzo dall'intervento, il divario è balzato subito agli occhi: il 96,5 per cento delle donne operate in maniera tradizionale non mostrava più alcun segno della malattia, rispetto all'86 per cento delle donne operate in maniera mininvasiva (presentavano un rischio di ripresa della malattia locale di quattro volte maggiore rispetto alle pazienti operate in aperto). E confrontando i tassi di sopravvivenza globale a tre anni dall'intervento, era vivo il 99 per cento delle donne operate ad addome aperto, rispetto al 93,8 per cento rilevato tra le pazienti operate in laparoscopia.
SCREENING: PIU' EFFICACE
IL PAP TEST O L'HPV TEST?
L'ANALISI
Immaginando di avere di fronte due gruppi, ognuno composto da cento donne colpite da un tumore del collo dell'utero, è come se nel campione delle pazienti a cui la malattia era stata asportata per via laparoscopica, quattro anni più tardi fossero rilevate dieci recidive in più (14 rispetto a 3,5). Mentre a tre anni di distanza, nel medesimo gruppo, risultavano decedute sei donne, a fronte di una (nel campione operato ad addome aperto). Numeri che, proiettati su larga scala, decretano il primato della chirurgia tradizionale. «Le conclusioni mettono in forte discussione il ricorso alla chirurgia laparoscopica tradizionale o assistita dal Robot nel trattamento del tumore della cervice uterina in stadio iniziale - afferma Alessandro Buda, responsabile dell'unità di ginecologia chirurgica oncologica all'Ospedale San Gerardo di Monza e unico italiano tra i firmatari della ricerca -. Indipendentemente da altri fattori in grado di incidere sul decorso della malattia, come l'età e il peso della donna, il tipo di cellule tumorali o il diverso grado di interessamento dei linfonodi, la chirurgia ad addome aperto rappresenta la soluzione più sicura per la cura di queste pazienti». L'analisi è stata condotta su donne colpite da tumori di dimensioni fino a quattro centimetri (a basso rischio): gli unici che vengono operati in prima battuta. Per quelli più grandi, in alcuni casi, si effettua una chemioterapia preoperatoria, al fine di ridurre la massa da asportare, anhce se lo standard è rappresentato dalla radioterapia associata alla chemioterapia.
Tumori del collo dell'utero: verso uno screening decennale con l'Hpv-test?
CONFERME ANCHE DA UN ALTRO STUDIO
Risultati analoghi sono emersi da un secondo lavoro pubblicato sempre sul New England Journal of Medicine, condotto analizzando i dati riportati nel National Cancer Database statunitense, da cui sono stati selezionati i dati di 2.461 donne sottoposte a isterectomia in seguito a un tumore della cervice uterina (a uno stadio iniziale): metà con approccio mininvasivo, metà con il taglio dell’addome. Ragionando in percentuali, le probabilità di decesso nei quattro anni successivi (le donne erano state operate tra il 2010 e il 2013) sono state del 9,1 (tra le pazienti operate in laparoscopia) e del 5,3 per cento. Differenze che, come nell'altra ricerca, non erano giustificate né dalle caratteristiche della malattia né dalla strategia terapeutica adottata. In questo caso, i ricercatori hanno potuto anche misurare le variazioni nel tempo dei tassi di sopravvivenza dopo un'isterectomia negli Stati Uniti. A partire dal 2006, anno in cui Oltreoceano ha iniziato a prendere piede la chirurgia mininvasiva robotica per il trattamento del tumore del collo dell'utero, la sopravvivenza ha iniziato a calare dello 0,8 per cento all’anno.
COSA CAMBIERA'?
A partire dagli Stati Uniti, l'approccio mininvasivo, supportato anche dalle linee guida della Società europea di ginecologia oncologica aggiornate a maggio, si è molto diffuso negli ultimi decenni. A «premiarlo» la possibilità di ridurre il sanguinamento durante l'intervento, il minor dolore, la riduzione dei tempi di degenza ospedaliera e il minor rischio di successive complicanze. Vantaggi che venivano colti come opportunità anche dalle donne, parzialmente rinfrancate dalla possibilità di ridurre l'impatto dell'intervento chirurgico. Ma di fronte a questi dati, considerando la sopravvivenza come il primo obbiettivo da raggiungere, «abbiamo il dovere di comunicare con chiarezza alle pazienti i risultati di questa ricerca e valutare in ogni donna i rischi e i benefici individuali dell’approccio mininvasivo rispetto all'isterectomia radicale a cielo aperto», prosegue Buda. Lo studio non dice da cosa possa dipendere la minore efficacia della chirurgia laparoscopica rispetto a quella tradizionale. «Una delle ipotesi che possiamo fare, trovandoci di fronte a interventi ugualmente efficaci in termini di radicalità chirurgica, riguarda l’impatto dell'anidride carbonica che si usa distendere l'addome nelle procedure laparoscopiche - conclude l'esperto -. I vortici gassosi che si vengono a creare nell’addome durante l'asportazione dell'utero potrebbero portare alcune cellule neoplastiche a insediarsi in un'altra sede. E a favorire così, nel tempo, la ripresa della malattia». Recidiva che, a quel punto, è molto più difficile da trattare. Ecco perché, a conti fatti, il bisturi (con ogni probabilità) rappresenta ancora la soluzione migliore.
Fonti

Fabio Di Todaro
Giornalista professionista, lavora come redattore per la Fondazione Umberto Veronesi dal 2013. Laureato all’Università Statale di Milano in scienze biologiche, con indirizzo biologia della nutrizione, è in possesso di un master in giornalismo a stampa, radiotelevisivo e multimediale (Università Cattolica). Messe alle spalle alcune esperienze radiotelevisive, attualmente collabora anche con diverse testate nazionali ed è membro dell'Unione Giornalisti Italiani Scientifici (Ugis).