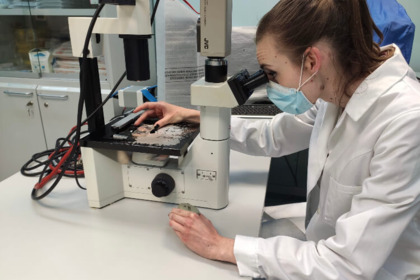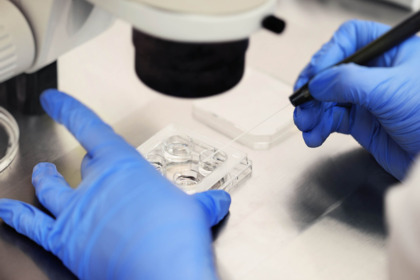Un nuovo nano-sistema biocompatibile potrebbe “indirizzare” e amplificare la radiotossicità sulle cellule tumorali: la ricerca di Giacomo Biagiotti
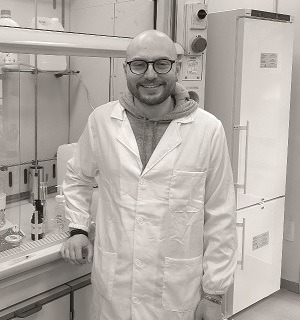
La radioterapia è una delle strategie più utilizzate per il trattamento dei tumori solidi, e consiste nell’indirizzare radiazioni ad alta energia sulla massa tumorale, distruggendo le cellule cancerose e limitando il danno ai tessuti sani vicini. Sebbene poco invasiva e non dolorosa, la radioterapia presenta tuttavia delle criticità, tra cui la possibile insorgenza di radioresistenza. Da qui la necessità di aumentare l’efficienza della tecnica utilizzando i cosiddetti radiosensibilizzanti, ovvero molecole in grado di captare le radiazioni e accelerare il processo di distruzione delle cellule malate. Giacomo Biagiotti è ricercatore post-doc presso l’Università degli Studi di Firenze, e il suo lavoro si concentra su una nuova gamma di materiali biocompatibili a base di nanoparticelle, in grado di veicolare e intrappolare una quantità significativa di agente radiosensibilizzante nelle cellule tumorali, in modo mirato. Questo progetto potrebbe aprire la strada a una nuova alternativa terapeutica da impiegare nel trattamento del tumore mammario triplo negativo o in forme tumorali radioresistenti. La sua attività di ricerca è supportata nel 2021 grazie a una borsa di studio di Fondazione Umberto Veronesi.
Giacomo, come nasce l'idea del vostro lavoro?
«Nasce dal desiderio di sviluppare una terapia non-invasiva ed efficace contro il tumore al seno triplo negativo. L’idea è combinare la radioterapia - ovvero uno degli approcci terapeutici più utilizzati per il trattamento dei tumori solidi - con i vantaggi che possono apportare le nanotecnologie in questo ambito».
Perché avete scelto di orientarvi su questa linea di ricerca?
«Perché aumentare l’efficacia della radioterapia è un obiettivo realmente raggiungibile, in particolare sfruttando le proprietà di materiali innovativi come le nanoparticelle e la biocompatibilità (cioè la compatibilità con i tessuti del corpo) dei nanomateriali a struttura carboidratica».
Quali sono gli aspetti poco noti da approfondire?
«Vorremmo studiare la possibilità di veicolare in modo selettivo e specifico delle molecole radiosensibilizzanti nella massa tumorale, in modo da avere un effetto citotossico selettivo. Altri punti da chiarire riguardano i meccanismi di accumulo delle nanoparticelle nel tumore».
Come intendete portare avanti il vostro progetto durante quest’anno?
«Il progetto è interdisciplinare e prevede fasi di attività strettamente integrate tra i gruppi di ricerca coinvolti, tra cui il Laboratorio GlycoFluoNano dell'Università di Firenze, il Program of New Drugs e Radiation Research Unit dell'Istituto Oncologico Europeo e il Soft Matter Nanotechnology Group, CIC biomaGUNE di San Sebastian in Spagna. In particolare, in una prima fase verranno preparati i vettori a struttura carboidratica opportunamente disegnati per veicolare in modo selettivo i radiosensibilizzanti nella massa tumorale. Successivamente verranno valutati l'uptake cellulare (ovvero la capacità di internalizzare il preparato, N.d.R.) e la radiotossicità indotta dal nostro nanosistema, impiegando modelli di tumore mammario triplo negativo».
Quali prospettive apre, anche a lungo termine, per la salute umana?
«Il progetto apre la strada allo sviluppo di sistemi radiosensibilizzanti di nuova generazione a base di nanotecnologie: funzionando come una sorta di “cavallo di Troia”, questi vettori permetterebbero di orientare la radiotossicità sulla massa tumorale e quindi di ridurre la dose di radiazioni da somministrare. Lo studio sarà realizzato sul tumore mammario triplo negativo, ma la tecnologia sviluppata potrebbe essere applicata anche per altri tipi di tumori, in particolare su quelli radioresistenti. Questa strategia potrebbe trovare applicazione anche nei trattamenti radioterapici eseguite nelle sale operatorie».
Giacomo, sei mai stato all’estero a fare un’esperienza di ricerca?
«Si, durante il mio dottorato ho avuto la possibilità di svolgere parte della mia attività di ricerca a Houston (USA), presso l’università del Texas MD-Anderson Cancer Center».
Cosa ti ha spinto ad andare?
«Principalmente il desiderio di confrontarmi con una realtà diversa da quella che considero la mia “confort-zone”, sia dal punto di vista lavorativo sia personale. Il lavoro che ho svolto ha riguardato la radiochimica e la biologia, materie con cui mi confrontavo per la prima volta sul campo. Inoltre, trovandomi a sei ore di fuso orario da tutti i miei amici e parenti, ho avuto modo di crescere come persona».
Che ricordi hai di questa esperienza?
«Non ho ricordi negativi. Certo, i primi giorni mi sono sembrati disastrosi, considerato che il mio appartamento - che in foto sembrava completamente arredato - era in realtà “unfurnished”, ovvero privo di arredo e corrente elettrica. Questo malinteso ha comportato un paio di notti passate sul pavimento, senza aria condizionata. A Houston, a giugno, ci sono circa 35°C con una umidità del 90%! Tuttavia, ripensandoci oggi, mi viene comunque da sorridere. Ho sentito la mancanza dell’Italia, ma in modo marginale: mi sono mancati gli amici, i genitori e la mia compagna, anche perché vedersi in video-chiamata non è sempre semplice quando ci sono sei ore di fuso orario».
Ricordi il momento in cui hai capito che la tua strada era quella della ricerca?
«Conseguita la laurea magistrale avevo deciso di lasciare il mondo accademico e di lavorare in azienda. Dopo circa un anno nei laboratori di analisi, mi sono trovato davanti ad un bivio: dovevo scegliere se accettare un assegno di ricerca o un posto in laboratorio di analisi ambientali. In quel momento decisi che volevo intraprendere la carriera accademica, conscio dei sacrifici che avrei dovuto affrontare».
Un momento della tua vita professionale che vorresti incorniciare e uno da dimenticare.
«Nella ricerca sono più i fallimenti dei successi; ci sono periodi in cui sembra che tutto vada storto e vorresti semplicemente chiudere il laboratorio e andare a casa. Poi succede che riesci a portare a termine il progetto, ti rechi da solo a un convegno internazionale dove ci sono i più grandi esperti del campo per presentarlo: quando vedi che molti di loro si interessano alla tua ricerca e si complimentano per il lavoro svolto, quel singolo momento ti ripaga di tutti gli sforzi che hai dovuto sostenere per arrivare lì. Per me quell’occasione fu il Chemontubes del 2018 a Biarritz, dove sono stato premiato con il premio miglior comunicazione poster».
Come ti vedi fra dieci anni?
«A capo di un gruppo di ricerca».
Se ti dico scienza e ricerca, cosa ti viene in mente?
«Futuro e innovazione».
Pensi che ci sia un sentimento antiscientifico in Italia?
«Non so se ci sia un sentimento antiscientifico, ma sicuramente c’è una ignoranza dilagante: siamo tra i Paesi con il numero di laureati più basso in Europa. Il dottorato stesso è considerato una perdita di tempo dalla maggior parte delle aziende. Ovviamente ci sono delle eccezioni, ma sono troppo poche».
Cosa fai nel tempo libero?
«Sono un amante della montagna, cerco di andarci ogni volta che posso: pratico trekking nei periodi estivi e snowboard in inverno. Sono anche appassionato di tecnologia e videogame».
Hai famiglia?
«Convivo con la mia ragazza».
Se un giorno tuo figlio o figlia ti dicesse di voler fare ricerca, come reagiresti?
«Sarei felice per la sua scelta e spererei che il suo cammino possa essere più semplice di quello che percorriamo noi oggi».
La cosa di cui hai più paura?
«La possibilità di ritrovarmi senza stipendio da un anno all’altro. Il timore è che tutto quello che ho costruito finora possa crollare come un castello di carte».
Sei soddisfatto della tua vita?
«Sto lavorando per esserlo in futuro».
La cosa che più ti fa arrabbiare?
«La continua e imperterrita diffusione di fake-news a carattere scientifico sui social».
Una “pazzia” che hai fatto?
«Non so se sia una pazzia, ma mi sono lanciato in tandem col paracadute da 4000 metri».
Giacomo, cosa vorresti dire alle persone che scelgono di donare a sostegno della ricerca scientifica?
«In Italia la ricerca nelle Università sopravvive grazie a ricercatori precari, pagati quasi esclusivamente con fondi privati. Il lavoro degli scienziati non produce né beni materiali né servizi, ma produce conoscenza e la conoscenza produce a sua volta innovazione. L’innovazione, specialmente in ambito medico, permette di migliorare la qualità della vita. Tutto questo ci ha permesso di crescere e progredire come società. In ambito oncologico questa affermazione è particolarmente vera: fino a pochi anni fa le terapie disponibili erano poche e scarsamente efficaci. Grazie alla ricerca e alle diagnosi precoci, le possibilità di guarire sono aumentate. Dal punto di vista terapeutico, c’è ancora molta strada da fare e le donazioni sono il carburante che serve alla macchina della ricerca per percorrere questa strada. Per questo mi sento in dovere di ringraziare tutti quelli che hanno deciso di donare in favore della ricerca».