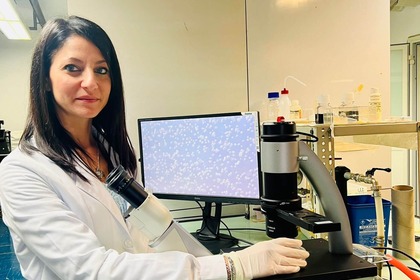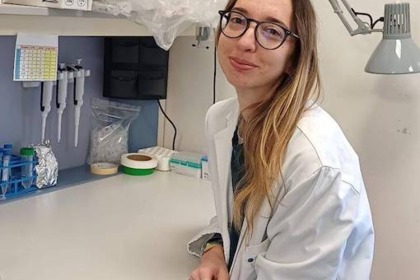Ilaria Prada studia a Milano i meccanismi attraverso cui le cellule immunitarie del cervello favoriscano la diffusione nelle aree cerebrali delle proteine tossiche nella malattia

Ilaria Prada, 35 anni di Milano, una laurea in Biotecnologie Farmaceutiche e un dottorato di ricerca in Medicina Molecolare, è una dei 24 ricercatori sostenuti nel 2015 da Fondazione Veronesi nell’ambito delle neuroscienze. Ilaria attualmente lavora nel laboratorio di Claudia Verderio, all’Istituto di Neuroscienze del Cnr di Milano e sviluppa un progetto sul morbo di Alzheimer. La malattia di Alzheimer è la forma di demenza più comune ed è causata dal deposito in placche di proteine anomale, come la proteina ?-amiloide e la proteina tau. Questi aggregati sono tossici, e causano la morte dei neuroni, con manifestazione della malattia. Le cause prime che portano alla formazione delle placche sono ancora in gran parte oscure. Con l’invecchiamento della popolazione, l’incidenza del morbo di Alzheimer sta aumentando con gravi ripercussioni sociali: il carico, fisico e psicologico, della malattia, infatti, non ricade solo sul paziente ma anche sui familiari. Attualmente non esistono terapie efficaci nel contrastare gli effetti della malattia; la ricerca scientifica, come quella condotta da Ilaria, è essenziale per capire i processi fisiopatologici che consentono di progettare farmaci e cure.
Ilaria, in cosa consiste il tuo progetto sul morbo di Alzheimer?
«Io mi occupo di capire il ruolo delle cellule immunitarie del cervello nell’espansione progressiva della malattia dall’area di origine ad altre zone del cervello. Queste cellule, chiamate microgliali, esercitano sui neuroni sia effetti protettivi sia dannosi. In studi precedenti abbiamo osservato che le cellule della microglia rilasciano, negli spazi negli extracellulari, microvescicole che contengono forme tossiche di ?-amiloide e di proteina tau. Le cellule della microglia, inoltre, sono in grado di spostarsi, “camminando” sulla superficie dei neuroni. Il mio obiettivo è quindi verificare l’ipotesi che le microvescicole gliali possano essere il mezzo tramite cui la malattia si diffonde progressivamente nel cervello».
Quali prospettive apre il tuo studio per la conoscenza biomedica e le eventuali applicazioni alla salute?
«Identificare le molecole chiave coinvolte in questi processi e quindi capire come avvenga la diffusione della neurodegenerazione, ci permetterà di sviluppare una nuova strategia per limitare la diffusione del danno cerebrale e, in ultima analisi, la progressione della demenza che è alla base della drammaticità di questa malattia».
Come molti tuoi colleghi, sei stata anche all’estero a fare ricerca. Cosa ti ha spinto ad andare e cosa ti ha lasciato quell’esperienza?
«Ho trascorso un anno del mio dottorato all’Università di Losanna, in Svizzera. Ho aumentato il mio bagaglio culturale sia tecnico-scientifico che umano. Sembra scontato dirlo, ma è stato proprio così! Credo che andare all’estero sia essenziale: se non si affrontano nuove sfide e non ci si mette di continuo alla prova, come si può essere bravi ricercatori?».
Come è stato il rientro in Italia?
«Sono dovuta rientrare in Italia per concludere il mio dottorato, ma non nascondo che se avessi potuto sarei rimasta fuori ancora un po’. Nel 2011 era molto più agevole fare ricerca in Svizzera, ad esempio non ci si doveva scontrare quotidianamente con le ristrettezze economiche che dobbiamo fronteggiare nei laboratori italiani. Nonostante le difficoltà, sono però convinta che sia giusto riportare in patria le conoscenze acquisite all’estero e, finché mi sarà permesso, cercherò di lavorare nel nostro paese. Se un giorno sarò costretta ad andarmene definitivamente dall’Italia per poter fare ricerca, lo farò perché amo il mio lavoro, ma non potrò nascondere un profondo senso di amarezza».
Ricordi il momento in cui hai capito che la tua strada era quella della ricerca?
«Fin da piccola sono sempre stata interessata alla medicina. Poi, la mia professoressa di scienze del liceo, Mila Necchi, ha portato nella nostra scuola nientemeno che il professor Renato Dulbecco. Ricordo questo incontro come un’illuminazione: per perseguire i miei obiettivi e dedicarmi alla medicina e allo stesso tempo soddisfare la mia naturale curiosità, la soluzione era…fare ricerca!».
C’è stato un momento da dimenticare nella tua carriera professionale?
«Con immensa amarezza ricordo il giorno in cui un gruppo di animalisti ha fatto irruzione nello stabulario dell’istituto dove lavoro, nel 2013. Non sto qui a descrivere lo scempio che è stato fatto dei nostri animali, riportato anche dalla stampa, ma posso testimoniare i sentimenti di ingiustizia ed impotenza che tutti noi abbiamo provato. Esperimenti in corso da lungo tempo, finanziati anche con le donazioni di cittadini privati, sono stati distrutti nel giro di qualche ora, in nome di qualcosa che non è né civile, né condivisibile. Non ci sono parole per descrivere la violazione subita e la pena che abbiamo vissuto anche nei confronti degli animali, che una volta liberati, sarebbero andati incontro a morte certa, non essendo in grado di sopravvivere nell’ambiente esterno».
Cosa ti piace di più della ricerca?
«Non vorrei risultare retorica, ma ciò che mi piace della ricerca è proprio la ricerca! Mi piace fare esperimenti diversi, discutere le proprie intuizioni e le proprie osservazioni con gli altri. Mi piace il fatto che ogni giorno sia diverso dall’altro».
E cosa invece eviteresti volentieri?
«Ciò che proprio non mi va giù del mondo della ricerca di oggi è la “rincorsa alla pubblicazione” e principalmente di dati positivi. Un tempo la pubblicazione era il naturale sbocco di qualunque attività di ricerca: se anche i risultati non corrispondevano a ciò che si era ipotizzato venivano resi pubblici con il solo scopo di condividere le proprie osservazioni con la comunità scientifica. Al giorno d’oggi la pubblicazione scientifica è diventata moneta di scambio per ottenere riconoscimenti e finanziamenti, però così si corre il rischio di snaturarla del suo scopo principale, la condivisione del sapere. Oggi la bravura di uno scienziato è misurata quasi esclusivamente dal numero di pubblicazioni e ciò non sempre corrisponde al vero. In questo modo poi, le ricerche che non producono risultati pubblicabili in breve tempo vengono penalizzate, ad esempio in termini di finanziamenti erogati. Altro aspetto è che, seguendo questa logica, i risultati negativi non sono condivisi. Ciò è un grande problema perché così ricercatori in laboratori diversi ripetono le stesse esperienze gli uni all’oscuro dei risultati degli altri, con spreco di tempo, energie e denaro».
Cos’è per te la ricerca?
«Tantissime cose. È curiosità, che è il vero motore della ricerca. È elasticità mentale, perché bisogna essere disposti a modificare le proprie ipotesi se il dato sperimentale non le conferma. È anche fatica, frustrazione e fallimento. Ma è soprattutto scoperta, successo, entusiasmo: nel momento in cui si interpretano correttamente i dati e si scopre qualcosa di prima sconosciuto tutti gli sforzi sono ripagati».

Chiara Segré
Chiara Segré è biologa e dottore di ricerca in oncologia molecolare, con un master in giornalismo e comunicazione della scienza. Ha lavorato otto anni nella ricerca sul cancro e dal 2010 si occupa di divulgazione scientifica. Attualmente è Responsabile della Supervisione Scientifica della Fondazione Umberto Veronesi, oltre che scrittrice di libri per bambini e ragazzi.