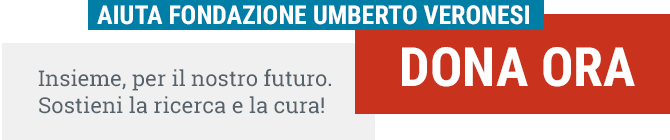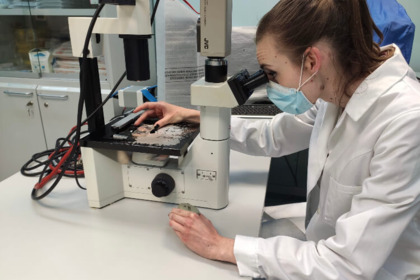Martina Gabrielli ha lavorato sei mesi a New York. Obiettivo: comprendere più a fondo le cause della più comune causa di demenza senile
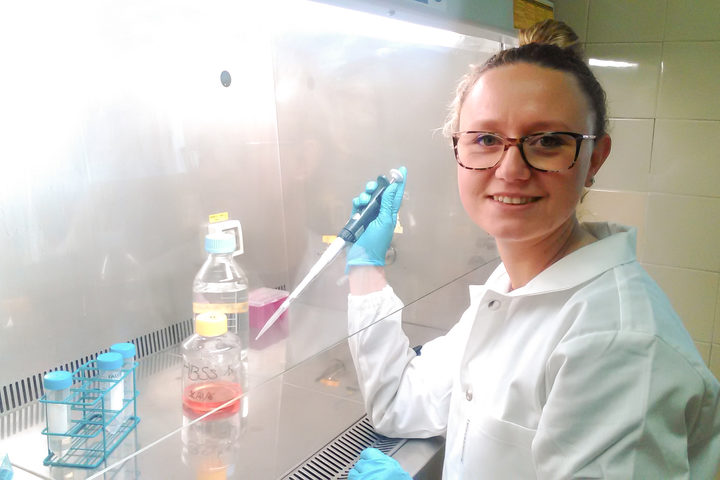
Il morbo di Alzheimer è associato all’accumulo di proteina beta amiloide al di fuori dei neuroni e all’aggregazione di proteina tau all’interno delle cellule. Una delle alterazioni riscontrate nelle fasi più precoci della malattia è il malfunzionamento della trasmissione fra sinapsi: non è tuttavia ancora noto come questa alterazione si generi e propaghi a diverse aree cerebrali. Diverse prove sperimentali suggeriscono un ruolo delle vescicole extracellulari, porzioni di membrana rilasciate dalla cellula per trasportare sostanze all’esterno, nello sviluppo della malattia. Queste vescicole assumono molteplici ruoli, tra cui quello di trasportare molecole-segnale da una cellula all’altra. Dati preliminari indicano che le vescicole isolate dal liquido cerebrospinale di pazienti affetti da Alzheimer contengono beta-amiloide e causano morte dei neuroni. Inoltre le vescicole prodotte da cellule microgliali - cellule del sistema immunitario presenti nel cervello - esposte alla proteina beta-amiloide sono in grado di destabilizzare le sinapsi e di compromettere i meccanismi alla base della memoria e dell’apprendimento. Una laurea in biotecnologie e un dottorato in scienze farmacologiche, Martina Gabrielli ha trascorso un periodo alla Columbia University di New York grazie al sostegno della Fondazione Umberto Veronesi, con l’obiettivo di chiarire in che modo le vescicole contenenti beta-amiloide danneggino i neuroni.
Martina, ci racconti più nel dettaglio il tuo progetto di ricerca?
«Lo scopo del mio progetto era quello di verificare il ruolo delle vescicole rilasciate dalle cellule microgliali nel malfunzionamento delle sinapsi nel morbo di Alzheimer. Per esempio, abbiamo messo singole vescicole contenenti proteine beta-amiloide a contatto con neuroni in coltura per analizzare le possibili alterazioni funzionali causate da una o più vescicole. I risultati indicano che le vescicole contenenti beta-amiloide sono effettivamente in grado di alterare la plasticità sinaptica in vitro, anche a quantità molto basse di beta-amiloide: questo suggerisce che queste vescicole svolgano un ruolo cruciale nello sviluppo dell’Alzheimer. Inoltre, le tecniche innovative che ho appreso grazie a questa esperienza mi saranno utili anche nel prossimo futuro per valutare in vivo gli effetti della proteina beta-amiloide sulla propagazione delle disfunzioni delle sinapsi tra diverse aree del cervello».
Quali prospettive potrebbero quindi aprirsi, anche a lungo termine, per chi soffre di Alzheimer?
«La malattia di Alzheimer è ad oggi la più diffusa tra tutte le malattie neurodegenerative. Purtroppo le attuali strategie terapeutiche che puntano alla riduzione dei livelli di proteina beta-amiloide presentano dei limiti. Ecco perchè chiarire il ruolo delle vescicole extracellulari contenenti beta-amiloide nello sviluppo della malattia è un passo importante per definire i meccanismi a valle degli aumenti di beta amiloide, che potrebbero costituire quindi nuovi bersagli terapeutici».
Martina, questa è stata la tua prima esperienza all’estero, giusto?
«Esatto: grazie al finanziamento della Fondazione Umberto Veronesi ho avuto l’occasione di lavorare per sei mesi presso il Taub Institute for Research on Alzheimer's Disease and the Aging della Columbia University. Ho aspettato questa occasione per molto tempo. È stata un’importante opportunità per specializzarmi nelle tecniche di elettrofisiologia e manipolazione ottica. Un’esperienza molto stimolante, che mi ha permesso di confrontarmi con una realtà lavorativa diversa rispetto a quella italiana».
Cos’è che ti ha fatto intraprendere la strada della ricerca?
«Ho sempre voluto un lavoro che conciliasse competenze diverse tra loro. Cercavo un lavoro dinamico, che mi permettesse di avere sempre cose diverse da fare e cose nuove da imparare, che mi spingesse di fatto al continuo miglioramento. Un lavoro che mi permettesse di viaggiare e che -piccolo sfizio personale - mi permettesse di imparare molto bene l’inglese. Ma soprattutto, un lavoro che rappresentasse un aiuto concreto per la società, che avesse un grande valore sociale ed etico».
C’è una figura che ti ha ispirato nella tua vita personale e professionale?
«La figura che più mi ha ispirato è sicuramente mio marito. Oltre a supportare la mia passione per la ricerca, è la persona che mi ha insegnato ad affrontare la vita ed il lavoro come faccio oggi: col sorriso. “Happiness is a mood, not a destination” è il nostro motto. Lui mi ha insegnato a non rimanere paralizzata di fronte ai grandi obiettivi, a non vederli come una “grande montagna” davanti a me, ma ad affrontare una cosa per volta, a vivere un giorno alla volta. E anche a prendere i fallimenti come parte del gioco e come un punto da cui ripartire».
Qual è per te il significato profondo del fare ricerca?
«L’apporto che ognuno di noi dà alla scienza è piccolo, ma è un passo avanti tutt’altro che insignificante. Ciascuno di noi aggiunge un pezzo in più ad un puzzle a cui tante tante persone hanno contribuito nel passato. Il puzzle non è ancora finito, ma ogni nostra scoperta ci fa avvicinare sempre di più al quadro completo, alla verità. Che è la verità su come funziona il corpo umano, ma non solo: quando ad esempio si studia il funzionamento del cervello di fatto si va oltre, si sfocia in concetti più filosofici che scientifici, a volte addirittura spirituali. E quando studi una patologia, ogni tassello è un passo in più verso la sua cura».
Cosa ne pensi dello stato della ricerca in Italia?
«Non mi piace il fatto che spesso la ricerca nel nostro paese non sia considerata un “vero lavoro”. Molti politici e cittadini pensano che sia il nostro “hobby”, che approfondiamo solo quello che ci interessa e che questo abbia poca o nessuna applicazione nel quotidiano. Questo è molto frustrante: la ricerca è fondamentale per la vita di tutti noi, anche quando le conseguenze sulla vita dei singoli cittadini non sono immediate. Ecco perché è importante sensibilizzare la società su questi temi: il mondo della scienza dovrebbe fare più comunicazione e farla meglio. La Fondazione Umberto Veronesi sta facendo un grande lavoro in questo senso».
A proposito di hobby (quelli veri), hai qualche passione al di fuori del laboratorio?
«Quando ero più piccola ho praticato atletica leggera a livello agonistico: lo sport mi ha insegnato che per raggiungere un obiettivo bisogna lavorare sodo, con costanza e determinazione, e che i limiti esistono solo nella nostra testa. Purtroppo non posso più allenarmi come una volta, ma esco a correre con piacere di tanto in tanto. Inoltre amo tantissimo la musica e vado spesso ai concerti. Guardo anche molte serie TV: le guardo in lingua originale in modo da potermi raccontare che sto di fatto studiando. Infine mi sono recentemente avvicinata alla fotografia: ho ricevuto la mia prima reflex proprio come regalo per aver concluso il dottorato di ricerca. Mi piace intrappolare quello che vedo e le emozioni che provo in un’immagine».
Hai qualche consiglio di lettura?
«Il mio libro preferito ad oggi è probabilmente “Il Budda, Geoff ed io”. È un romanzo tratto da una storia vera, che racconta di come un approccio positivo alla vita possa creare una specie di “effetto domino” e migliorare ogni aspetto della nostra esistenza. Parla anche di come ciascuno di noi, sebbene spesso non ne sia cosciente, abbia già dentro di sé tutti gli strumenti per poter realizzare qualsiasi cosa».

Agnese Collino
Biologa molecolare. Nata a Udine nel 1984. Laureata in Biologia Molecolare e Cellulare all'Università di Bologna, PhD in Oncologia Molecolare alla Scuola Europea di Medicina Molecolare (SEMM) di Milano, Master in Giornalismo e Comunicazione Istituzionale della Scienza all'Università di Ferrara. Ha lavorato nove anni nella ricerca sul cancro e dal 2013 si occupa di divulgazione scientifica