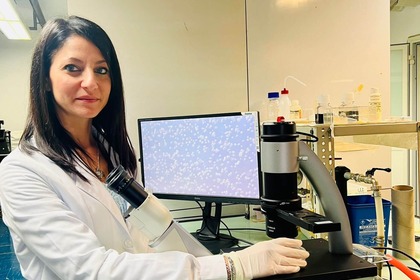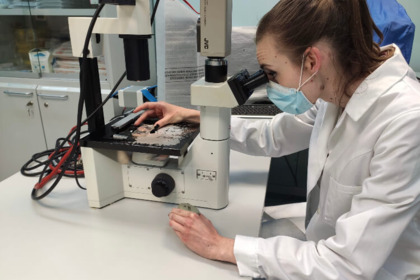I farmaci per la leucemia linfatica cronica hanno aperto nuove possibilità per i pazienti. Ma esistono più “forme” della stessa proteina, ed è fondamentale capire il perché: la ricerca di Andrea Mazzarello
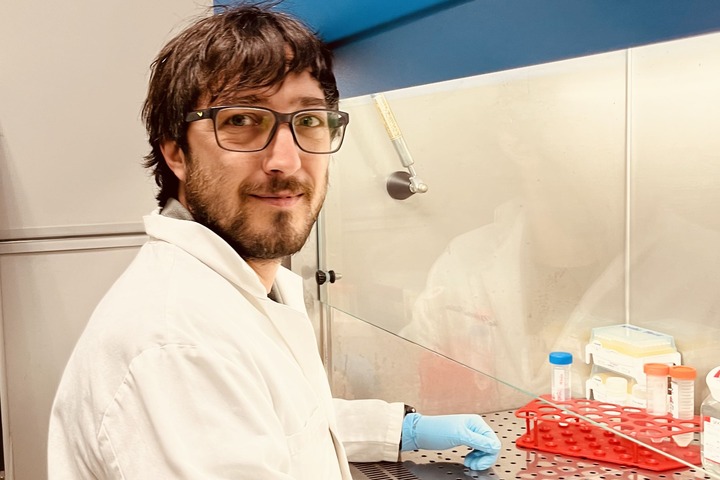
La leucemia linfocitica cronica è una forma tumorale caratterizzata dall'accumulo di linfociti B maturi nel sangue, nel midollo osseo, nei linfonodi e nella milza. Si tratta della leucemia più frequente nelle persone di età adulta-anziana, ed è definita cronica per via del suo tipico decorso lento e spesso senza sintomi significativi per il paziente. In una frazione dei casi, una volta completata la diagnosi, si può scegliere di attendere il decorso della malattia (sorveglianza attiva) con controlli periodici ed evitando il ricorso alle terapie. In altri casi, invece, è necessario il trattamento con chemioterapici o anticorpi monoclonali (farmaci di precisione, diretti contro uno specifico bersaglio molecolare). Andrea Mazzarello è ricercatore presso l’Università degli Studi di Genova, dove studia i meccanismi molecolari connessi all’attività di alcune proteine presenti sui linfociti B - chiamate immunoglobuline. Obiettivo del progetto sarà studiare due varianti simili (ma non identiche) di un’immunoglobulina presente sui linfociti, coinvolta nella progressione della leucemia e nella resistenza ai farmaci. Il progetto sarà sostenuto per il 2024 da una borsa di ricerca di Fondazione Veronesi.
Andrea, come nasce l'idea del vostro lavoro?
«La leucemia linfocitica cronica è ancora una malattia difficilmente “guaribile”, nonostante negli ultimi anni i metodi di terapia abbiano significatamene migliorato la qualità di vita dei pazienti. Il nostro lavoro nasce dalla necessità di comprendere meglio i meccanismi con cui queste cellule tumorali imparano a espandersi e a resisteste alle attuali terapie. Individuare questi meccanismi permetterà di disegnare nuovi farmaci, migliorando l’efficienza delle terapie».
Perché avete scelto questa linea di ricerca?
«Le cellule leucemiche utilizzano le immunoglobuline di membrana (delle molecole presenti sulla superficie delle cellule, N.d.R.) per promuovere la loro stessa crescita. Per questo motivo, la maggior parte dei farmaci oggi in uso, chiamati inibitori delle tirosin-chinasi, sono sviluppati per bloccare la funzione di queste immunoglobuline. Occorre però comprenderne meglio il funzionamento, così da sviluppare altre opzioni terapeutiche in caso di resistenza ai farmaci di prima linea».
Quali sono gli aspetti poco noti?
«Nella maggior parte dei casi, le cellule leucemiche presentano contemporaneamente due diverse immunoglobuline di membrana, chiamate IgM e igD, che sono simili ma non identiche tra loro. Per decenni si è pensato che non ci fossero differenze nel loro ruolo per la promozione tumorale. Dati più recenti, invece, hanno dimostrato che i loro ruoli sono complementari, ma diversi. Noi speriamo di poter approfondire i meccanismi molecolari e genetici alla base delle loro diverse funzioni».
In che modo?
«Manipoleremo le cellule leucemiche in modo che utilizzino solo una versione dell’immunoglobulina alla volta; in questo modo, potremo confrontare le differenze nella sopravvivenza e crescita tumorale. Poi valuteremo quali “vie di segnalazione cellulare” vengono utilizzate dalle cellule tumorali: un po' come identificare quali cavi elettrici, in una casa, arrivano a una specifica presa. Infine, proveremo a “tagliare” i cavi che sembreranno essere associati con funzioni tumorali, usando molecole che potrebbero avere un’applicazione in terapia».
Quali sono le vostre prospettive, anche a lungo termine?
«Capire meglio il funzionamento delle immunoglobuline nella leucemia linfatica cronica potrà portare allo sviluppo di nuove e più efficaci terapie per questa patologia. Inoltre, le immunoglobuline hanno una funzione importante in tutte le cellule B. Quindi, nel lungo periodo, i meccanismi identificati potrebbero essere validati in un contesto ancora più ampio».
Andrea, sei mai stato all’estero per un’esperienza di ricerca?
«Sì, ho vissuto per dieci anni negli Stati Uniti, dove ho lavorato presso il Feinstein Institute for Medical Research di New York».
Cosa ti ha spinto ad andare?
«La scelta è stata sia professionale che personale. Ho sempre desiderato confrontarmi con un mondo diverso da quello in cui sono cresciuto e fin dall’inizio della mia carriera di ricercatore ho coltivato il desiderio di conoscere il sistema scientifico statunitense».
Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
«Mi ha fatto crescere come persona e come professionista: ho imparato a vivere e comunicare in un mondo dove la diversità di culture e di pensiero è parte della vita di tutti i giorni».
Hai qualche episodio particolare che ti è capitato durante il tuo lavoro?
«Non ho un episodio specifico. Ho sempre trovato interessante che i giovani ricercatori potessero interagire nella quotidianità con grandi scienziati. Per esempio, dopo un seminario, mi ritrovai a pranzo con Jennifer Doudna, che vinse il Premio Nobel pochi anni dopo. Ebbi la possibilità di chiederle direttamente alcune “dritte” sulla tecnica da lei sviluppata. Relatori come lei venivano invitati settimanalmente ed erano sempre disponibili e aperti alle discussioni».
C’è un momento della tua vita professionale che vorresti incorniciare e uno invece che vorresti dimenticare?
«Incornicerei la prima volta in cui presentai i miei risultati a un congresso internazionale. Invece non ci sono momenti negativi che cancellerei: nel lungo periodo diventano sempre motivo di crescita e perdono la loro connotazione negativa».
Cosa ti piace di più della ricerca?
«La sua imprevedibilità: i dati spesso e volentieri ti obbligano a cambiare l’idea che avevi ipotizzato prima di generarli».
E cosa invece eviteresti volentieri?
«In generale, la macchinosità attuale della burocrazia».
C’è una figura che ti ha ispirato nella tua vita personale o professionale?
«Il mio mentore a New York, il dott. Nicholas Chiorazzi».
Qual è l’insegnamento più importante che ti ha lasciato?
«Che è importante essere una brava persona, oltre che un bravo scienziato, e che un gruppo complesso con tante individualità funziona meglio quando si promuove uno spirito di cooperazione, anziché di competizione».
Cosa avresti fatto se non avessi fatto il ricercatore?
«È un “cosa-se” difficile da sapere. Durante l’ultimo anno di superiori andai avevo scelto due possibili lavorativi: uno è quello che ho intrapreso, l’altro riguardava l’accademia aereonautica. Erano due mezzi diversi per un fine simile».
In cosa, secondo te, può migliorare la scienza e la comunità scientifica?
«Dovremmo iniziare a dare maggior valore ai dati negativi, che oggi sono difficili da pubblicare. Un lavoro del tipo: “Ho provato a raggiungere un risultato con questa metodologia, ma non è stato possibile” difficilmente verrebbe accettato per la pubblicazione. Invece, sapere che quella strada è già stata tentata e non è percorribile aiuterebbe tutti a risparmiare tempo e fatiche».
E in che modo e da chi, invece, potrebbe essere aiutato il lavoro di chi fa scienza?
«Chiunque può aiutare il lavoro di chi fa scienza. Anche solo essere consapevoli di quanto sia indispensabile per migliorare la nostra società sarebbe sufficiente per portare a cambiamenti strutturali e a un lavoro più efficace».
Pensi che ci sia un sentimento antiscientifico in Italia?
«È una domanda complicata che meriterebbe una risposta molto lunga. C’è sicuramente qui, come altrove, una frangia antiscientifica “a priori”, ma non credo sia un sentimento così diffuso. Dovremmo chiederci come mai esistono persone senza gli strumenti necessari per capire cosa sia la scienza e dovremmo evitare di ripetere gli stessi errori con le nuove generazioni».
Cosa fai nel tempo libero?
«Un tempo hiking e corsa, ultimamente non molto».
Se un giorno tuo figlio o tua figlia ti dicesse che vuole ricerca, come reagiresti?
«Spiegherei i lati positivi e negativi della mia esperienza, poi la scelta sarebbe la loro. Si può equamente scegliere di lavorare per vivere o di vivere per lavorare».
Hai un ricordo a te caro di quando eri bambino?
«Il tempo trascorso nel laboratorio di falegnameria del nonno. Ai tempi non fui capace di apprezzare abbastanza quello che mi veniva trasmesso».
Il libro che più ti piace?
«Il paradiso degli orchi, di Daniel Pennac».
Con chi ti piacerebbe andare a cena una sera e cosa ti piacerebbe chiedergli?
«Con Alexandria Ocasio-Cortez: mi piacerebbe chiederle qualche dettaglio sulle sue idee politiche».
Perché è importante donare a sostegno della ricerca scientifica?
«Le donazioni sono il pilastro su cui si erge una ricerca libera e indipendente, requisiti fondamentali per scoperte con impatti significativi a lungo termine. Faccio due esempi a me vicini: il primo riguarda l’Istituto in cui ho lavorato per molti anni. Si chiama The Feinstein Institutes for Medical Research, perché prende il nome dalla famiglia Feinstein che donò i fondi necessari per svilupparlo. In meno di 20 anni la ricerca in questo Istituto ha portato a scoperte eccezionali nei campi dell’oncologia, dell’autoimmunità e della medicina bioelettronica. Il secondo esempio riguarda il mio mentore: il supporto di donatori e fondazioni no profit è stato essenziale per il suo lavoro e per giungere a scoperte che hanno rivoluzionato il trattamento e la prognosi della leucemia linfatica cronica».
E cosa vorresti dire alle persone che scelgono di donare a sostegno della ricerca scientifica?
«Che il loro contributo è fondamentale e li ringrazio dal profondo del cuore. Senza questi aiuti non saremmo dove siamo e non avremmo a disposizione le terapie e gli strumenti che migliorano la qualità della vita dei pazienti, ogni singolo giorno»