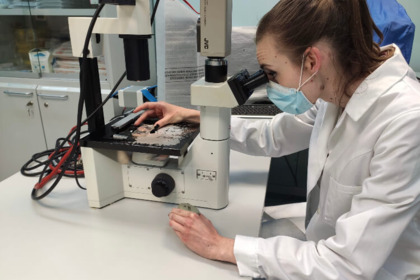Molti casi di depressione maggiore non traggono giovamento dai trattamenti. Chiara Fabbri analizzerà le varianti genetiche dei pazienti per capire in anticipo chi probabilmente non risponderà ai farmaci

Nonostante i tabù che ancora oggi spesso impediscono di parlarne apertamente, i disturbi depressivi hanno un impatto importante sul benessere individuale: a livello mondiale rappresentano infatti una delle prime cause di disabilità sia fra i giovani a partire dai 15 anni sia fra gli adulti. Il disturbo depressivo maggiore da solo è responsabile di circa il 15 per cento dei giorni vissuti con disabilità in Europa, ed è stato stimato che la riduzione nella qualità della vita arrecata da questa condizione sia paragonabile a quella provocata da malattie fisiche gravi come le cardiopatie e l’artrite.
Nella pratica clinica corrente la scelta dell’antidepressivo è guidata da criteri clinici generici, e circa un paziente su tre dei pazienti non registra una risposta soddisfacente a due o più antidepressivi (sono cioè resistenti). Oggi sono disponibili più di trenta differenti trattamenti farmacologici, il che suggerisce che pazienti diversi presentino disfunzioni a livello di meccanismi biologici diversi. Ecco perché sarebbe importante identificare marcatori che possano essere analizzati in ciascun soggetto e che possano guidare i medici nella prescrizione del farmaco più appropriato per ogni situazione. Chiara Fabbri ha ottenuto un finanziamento della Fondazione Umberto Veronesi per svolgere un periodo di ricerca presso il King’s College di Londra, a caccia di differenze genetiche che possano fungere da marcatori.
Chiara, ci descrivi nel dettaglio il contenuto del tuo progetto di ricerca?
«L’individuazione di marcatori biologici è un obiettivo cruciale per poter personalizzare i trattamenti per il disturbo depressivo maggiore. Tra i possibili tipi di biomarcatori le varianti genetiche appaiono particolarmente promettenti: lo scopo del mio progetto è identificare quelle associate al rischio di resistenza agli antidepressivi. Verranno studiate varianti genetiche rare e comuni in un campione di quasi 1350 pazienti affetti da disturbo depressivo maggiore in terapia farmacologica, inclusi 455 pazienti resistenti al trattamento. Le analisi si concentreranno su gruppi di geni che siano correlati dal punto di vista funzionale, in modo da tenere in considerazione la natura complessa e poligenica (cioè dipendente da un insieme di geni più che da uno singolo) della risposta antidepressiva, per poter identificare un profilo genetico di rischio di resistenza al trattamento farmacologico».
Le varianti genetiche potrebbero quindi in futuro avere un ruolo chiave nella scelta del trattamento?
«Esatto, e poter personalizzare gli interventi farmacologici migliorerebbe decisamente la qualità di vita per questi pazienti. Non solo: permetterebbe di ridurre l’impatto socio-economico dei disturbi depressivi. Solo nel 2010 le persone in Europa che hanno sofferto di depressione erano trenta milioni, con un costo stimato di 92 miliardi di euro».
Chiara, per questo progetto lavorerai a Londra presso il King’s College: tu avevi già avuto un’esperienza in questo prestigioso istituto, giusto?
«Sì, per un anno: tra il 2015 e il 2016. Il dipartimento universitario che mi ha già ospitato e in cui sono tornata per questo progetto è tra i leader europei nella creazione, sviluppo e applicazione di metodi di analisi statistica in ambito genetico. È inoltre un contesto eterogeneo, ricco di figure di ricerca con background diversi: bioinformatici, biologi, psicologi, statistici. La mia prima esperienza è stata l’occasione per far nascere una collaborazione a lungo termine con questo dipartimento: a tutt’oggi condividiamo e portiamo avanti progetti di ricerca comuni, come quello finanziato dalla Fondazione Umberto Veronesi».
Quando hai scelto di dedicarti alla ricerca, e perchè?
«Ho iniziato mentre frequentavo il quinto anno di Medicina, soprattutto perché pensavo avrebbe migliorato la mia formazione come futura psichiatra. Col passare del tempo però ho iniziato a vederla non più come un semplice integrazione delle mie conoscenze mediche, ma come una parte complementare fondamentale della mia attività clinica: mi dà la possibilità di contribuire al miglioramento delle conoscenze e quindi della cura dei pazienti. La spinta a produrre qualcosa di nuovo e utile è proprio quello che per me neutralizza la cosiddetta routine quotidiana».
Una figura che ti ha ispirato nella tua vita personale e lavorativa?
«Una persona con una grave malattia psichiatrica, presente nel mio nucleo famigliare, ha senz’altro contribuito a ispirare le mie scelte in ambito professionale».
C’è un momento della tua vita professionale che vorresti dimenticare?
«Alcuni anni fa alcuni preziosi colleghi si sono dovuti trasferire all’estero per continuare a fare ricerca: mancavano le risorse per dare loro un posto di lavoro in Italia. O la volontà».
Un episodio particolare che ti è successo durante il lavoro?
«Mi è capitato di dimenticarmi completamente dell’orario e di lavorare fino a notte o al mattino».
Cosa fai nel tempo libero?
«Leggo, faccio passeggiate nella natura, viaggio e cerco di passare del tempo con le persone care».
Il tuo film preferito?
«“A beautiful mind”. Una menzione speciale per “Il piccolo diavolo” di Benigni, che mi fa sempre ridere a crepapelle».
La cosa di cui hai più paura.
«Morire con la sensazione di non aver vissuto come avrei voluto, perché non penso avrò un’altra vita».
La cosa che più ti fa arrabbiare.
«Le polemiche di chi sa criticare ma non proporre una soluzione migliore».
Cosa ne pensi delle persone che si oppongono ai pareri della comunità scientifica per motivi espressamente ideologici?
«Internet ha donato a tutti l’opportunità di accedere virtualmente a infinite possibilità conoscitive. Già quando andavo al liceo era diventato comune fare i compiti o svolgere ricerche consultando Wikipedia, oggi spesso si va oltre. Penso che l’uso massivo del web e dei social network stia paradossalmente producendo un abbassamento del livello di cultura in certe fasce della società, per la diffusione molto più rapida e una resa più accattivante di informazioni false, parziali o tendenziose. Informazioni come queste circolavano anche in passato, ma oggi riescono a diffondersi molto più facilmente ed estesamente. La soluzione sta nelle scuole, che dovrebbero aiutare a formare la cultura delle persone».

Agnese Collino
Biologa molecolare. Nata a Udine nel 1984. Laureata in Biologia Molecolare e Cellulare all'Università di Bologna, PhD in Oncologia Molecolare alla Scuola Europea di Medicina Molecolare (SEMM) di Milano, Master in Giornalismo e Comunicazione Istituzionale della Scienza all'Università di Ferrara. Ha lavorato nove anni nella ricerca sul cancro e dal 2013 si occupa di divulgazione scientifica