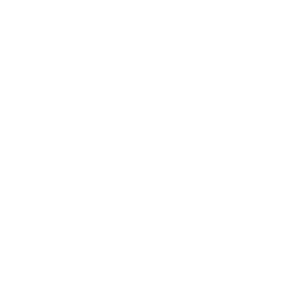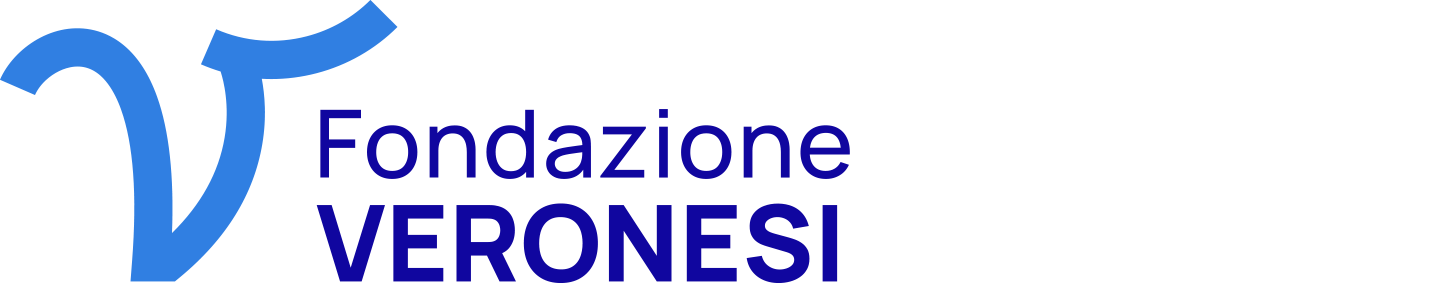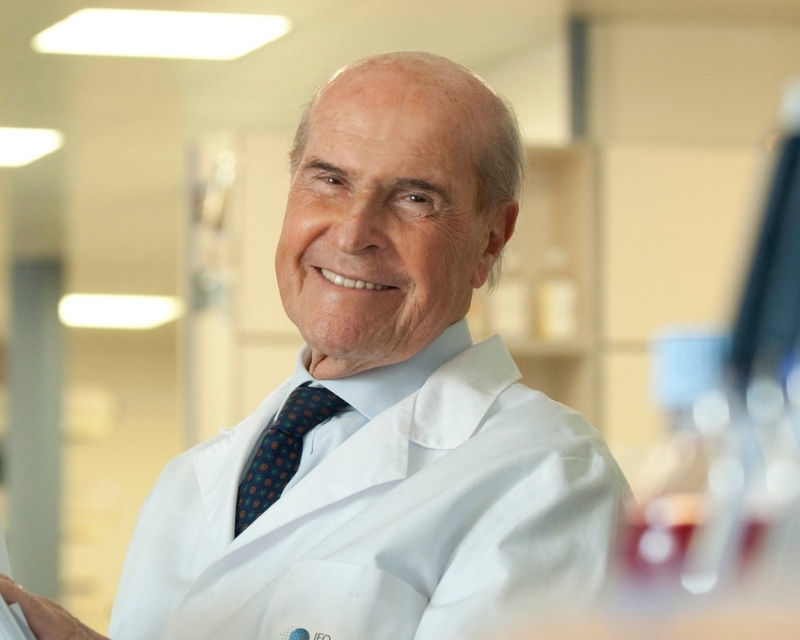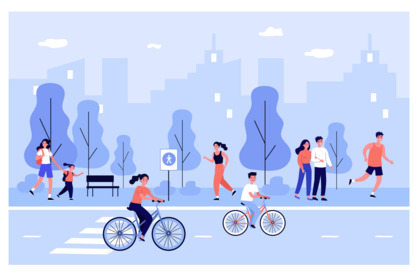Anoressia, bulimia e binge eating disorder colpiscono milioni di persone. Perlopiù ragazzine, nessuno le conta davvero e i posti nei centri sono 900

«Erano circa 3,5 milioni nel nostro paese. Adesso si ipotizza siano almeno 5 milioni a soffrire di anoressia, bulimia, binge eating disorder. Molte sono poco più che bambine, appena dieci o undici anni, altre appena più grandi», esordisce Leonardo Mendolicchio, psichiatra e responsabile dei Disturbi dell’Alimentazione, Istituto Auxologico Italiano, introducendo una malattia sempre più diffusa tra bambini e adolescenti, quella dei disturbi del comportamento alimentare.
CHE COSA SONO I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
È un contenitore gigantesco al cui interno si collocano manifestazioni e patologie differenti come anoressia, bulimia, binge eating disorder (disturbo da alimentazione incontrollata, BED), tutte quante accomunate da una grande sofferenza psicofisica e da un rapporto conflittuale e faticoso con il cibo, che è ovviamente la spia di dinamiche psicologiche estremamente complesse.
CHI E QUANTE SONO LE PERSONE COLPITE DA ANORESSIA E BULIMIA
«In genere, hanno massimo sedici anni e sono quasi tutte femmine (circa il 90%) - prosegue Mendolicchio -. I dati sono allarmanti. E lo sono ancora di più, al di là del numero enorme di casi, se si considera che sono dati dettati unicamente dall’esperienza empirica (numero di richieste visite specialistiche e accessi ospedalieri) e non dall’esistenza di precisi riferimenti epidemiologici e appositi registri. Inoltre si tratta di numeri in costante e continuo aumento con un’impennata (più 45%) nel post lockdown e un abbassamento dell’età dell’esordio che avviene due o tre anni rispetto al pre-pandemia, addirittura alla fine della scuola primaria».
I CENTRI SONO POCHI E MAL SEGNALATI
Situazione resa ancora più complessa dalla difficoltà di prendersi cura in maniera adeguata di queste bambine e ragazze e delle loro famiglie. «Perché è una malattia che impatta in maniera devastante su tutto il nucleo familiare» spiega Stefano Erzegovesi, psichiatra, nutrizionista e divulgatore scientifico nell'ambito della sana alimentazione e dei disturbi del comportamento alimentare. «Deve essere presa in carico, il prima possibile, da una équipe multidisciplinare che preveda almeno tre figure: medico, nutrizionista e psicologo. L’iter normalmente inizia con il pediatra e/o medico di base che dovrebbe segnalare alla famiglia un centro di riferimento specialistico presente sul territorio. Ma la mappa dei centri è spesso sguarnita, soprattutto in alcune zone d’Italia. Sono pochi, quasi inesistenti al centro-sud e, qualora ci siano e siano pure eccellenti, mal segnalati. E anche i più importanti centri di riferimento, situati soprattutto al nord, non riescono comunque a supplire alla domanda sempre più crescente». Solo quest'anno è stata pubblicata una mappa dei centri specializzati elaborata dal Centro dipendenze e doping dell'Istituto superiore di Sanità: una novantina i centri censiti, che hanno in carico 8.000 utenti circa.
MILIONI DI RAGAZZE COLPITE. E 900 POSTI LETTO
«Attualmente i letti a disposizione per gli eventuali ricoveri sono nel complesso in Italia, tenendo conto degli ospedali, delle comunità e dei centri diurni, solo circa 900», sottolinea Mendolicchio, «un numeroso dunque infinitesimale rispetto ai bisogni effettivi». Ovviamente poi per i casi più gravi, in relazione alle necessità, si ricorre ai ricoveri presso i reparti di Pediatria e Medicina Generale. «E pensare che circa il 10% di queste ragazze non ce la fa - afferma Erzegovesi - fa gelare il sangue perché si tratta di giovanissime, prive di altre patologie e quindi “altrimenti sane”».
LE RAGIONI DEL DILAGARE DI QUESTA EPIDEMIA
Quali le ragioni di questo terrificante aumento esponenziale dei casi? Le motivazioni sono molte articolate e complesse e, come per quasi tutte le patologie, multifattoriali, concordano gli esperti. A cominciare da una acuita sensazione di solitudine, dovuta alla mancanza ancora più evidente di contatti fisici e rapporti reali con i coetanei nella fase più acuta della pandemia. «Ci sono poi le numerose pressioni sociali a cui i più giovani sono continuamente sottoposti - prosegue Mendolicchio - dai modelli estetici irraggiungibili imperversanti in rete, alle aspettative eccessive da parte della famiglia e della società in genere che chiede di essere iper performanti, sempre». «Va sottolineato però un aspetto importante - prosegue Erzegovesi – ovvero che la famiglia non si deve mai colpevolizzare, ma deve partecipare in maniera attiva al percorso di cura della ragazza e dell’intero nucleo familiare. Per cui è imprescindibile che sia supportata in modo adeguato e venga coinvolta in toto, anche in maniera pratica, affidando mansioni precise da condividere, come la preparazione dei pasti, il momento in cui si apparecchia la tavola…».
QUALI I SINTOMI CHE DEVONO METTERE IN ALLERTA I GENITORI?
Premesso che intervenire il prima possibile fa la differenza sostanziale nell'affrontare i disturbi del comportamento alimentare, ci sono segnali anche piuttosto evidenti, che vanno colti. «Un viso più scavato, silenzi reiterati, la percezione di una tensione di fondo che porta a sbalzi d'umore - prosegue Erzegovesi - costituiscono indicatori molto precisi insieme a una ritualità un po’ ossessiva che diventa sempre più invadente: il cibo viene sminuzzato in piccoli pezzi, i bocconi sono minuscoli e i pasti diventano sempre più lenti. Muta insomma il modo di stare a tavola che si trasforma in un momento molto faticoso, che genera, anche visibilmente, sofferenza. l rapporti con gli altri cambiano e le relazioni sociali si riducono. Anche l’assentarsi immediatamente dopo il pasto per andare in bagno è un segnale importante, così come le lamentele continue circa il proprio aspetto fisico. “Ho le gambe grosse, ho la pancia, ho il volto troppo paffuto….”. Anche in questo caso è il reiterarsi prolungato di queste affermazioni, è la loro ripetitività che deve costituire motivo di preoccupazione, spingendo il genitore a rivolgersi al medico. Non l’affermazione buttata lì una volta ogni tanto, tipica invece dell’età adolescenziale».
ASPETTATIVE FUTURE
Il riconoscimento di una malattia complessa che non è affatto un capriccio di una ragazzina noiosa e viziata che non vuole mangiare e, di conseguenza, la messa in atto di strategie di gestione sul territorio e di fondi a disposizione per la gestione solerte di una patologia che richiede competenza e dialogo. I disturbi del comportamento alimentare sono l’emblema di una cura fatta di parole, azioni, conoscenze scientifiche perché è una malattia che impatta su tutto il corpo e sull’anima. Stravolge una vita giovanissima e quella di tutti i suoi cari.
Sostieni la ricerca scientifica d'eccellenza e il progresso delle scienze. Dona ora.

Paola Scaccabarozzi
Giornalista professionista. Laureata in Lettere Moderne all'Università Statale di Milano, con specializzazione all'Università Cattolica in Materie Umanistiche, ha seguito corsi di giornalismo medico scientifico e giornalismo di inchiesta accreditati dall'Ordine Giornalisti della Lombardia. Ha scritto: Quando un figlio si ammala e, con Claudio Mencacci, Viaggio nella depressione, editi da Franco Angeli. Collabora con diverse testate nazionali ed estere.