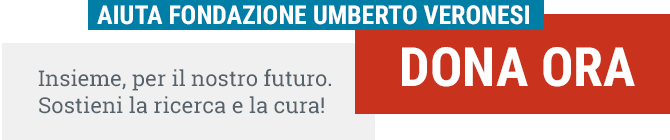Le disfunzioni dei mitocondri sono associate a malattie neurodegenerative come il Parkinson. Claudia Zanna punta a ripristinare la loro funzionalità come opzione terapeutica

Il morbo di Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa, dopo l’Alzheimer. Dal punto di vista anatomico, è caratterizzato dalla perdita progressiva di cellule in un’area profonda del cervello, chiamata sostanza nera, che produce la dopamina, un neurotrasmettitore fondamentale per il controllo dei movimenti. Come risultato, i sintomi tipici della malattia sono tremori, rigidità muscolare, problemi di equilibrio e postura, lentezza nei movimenti e difficoltà a parlare. Deficit che rendono difficile svolgere le normali attività quotidiane.
Le cause del Parkinson non sono ancora del tutto chiare. In passato sono stati proposti diversi geni e fattori ambientali come possibili concause e, solo di recente, alcuni studi hanno acceso i riflettori sul possibile ruolo dei mitocondri. Questi organelli cellulari sono essenziali per produrre energia e svolgono quindi un ruolo cruciale in tutti i processi vitali della cellula. Un loro malfunzionamento determina l’insorgenza di problemi a livello di tutti i tessuti e i più colpiti sono quelli che utilizzano molta energia, come i muscoli e il cervello.
Con il supporto di una borsa di ricerca di Fondazione Umberto Veronesi, Claudia Zanna, biologa dell’Università di Bologna, valuterà l’efficacia di molecole già utilizzate nel trattamento delle patologie mitocondriali come possibile terapia per il morbo di Parkinson.
Claudia, vuoi dirci qualcosa di più sui mitocondri e sul loro funzionamento?
«I mitocondri sono dei piccoli organelli presenti all’interno di tutte le cellule. Oltre a produrre l’energia necessaria per le funzioni vitali, i mitocondri hanno un ruolo chiave nella regolazione dell’apoptosi, un tipo di morte cellulare programmata, che mantiene costante il numero di cellule presenti nei tessuti eliminando quelle invecchiate o con danni al Dna. Se questo processo non funziona correttamente, le cellule muoiono più di quanto dovrebbero e questo meccanismo potrebbe essere implicato nell’insorgenza di malattie neurodegenerative come il Parkinson».
Esistono delle molecole particolarmente importanti in questo processo?
«Da anni mi occupo di OPA1, una proteina che regola la forma dei mitocondri e le cui alterazioni si traducono nella morte progressiva delle cellule. Mutazioni di OPA1 sono comunemente associate all’atrofia ottica dominante, una malattia genetica caratterizzata dalla morte dei neuroni che trasmettono il segnale visivo dall’occhio al cervello. Ma il mio laboratorio ha recentemente identificato mutazioni di OPA1 anche in pazienti con il Parkinson».
È possibile fare qualcosa per rimediare alle mutazioni di questa proteina?
«Fortunatamente sì: oggi esistono nove molecole capaci di riattivare le funzioni energetiche dei mitocondri compromesse da mutazioni di OPA1. Queste sostanze sono approvate dalla Food and Drug Administration e sono già utilizzate per il trattamento di diverse patologie».
Si può pensare di utilizzare questi farmaci per il trattamento del Parkinson?
«Sì, ma prima è necessario valutarne sperimentalmente l’efficacia. Nel mio progetto prevedo pertanto di valutare l’effetto di queste molecole prima su cellule di topo con mutazioni di OPA1 e, in seguito, su cellule umane con le stesse mutazioni e provenienti da pazienti con il morbo di Parkinson. I risultati del mio studio permetteranno di valutare OPA1 come nuovo bersaglio terapeutico per il Parkinson e di caratterizzare il meccanismo d’azione delle molecole in grado di ripristinarne la funzione. Questi farmaci sono già approvati, se efficaci, potrebbero essere validati velocemente anche per il trattamento del Parkinson».
Raccontaci di te. Il tuo lavoro ti ha mai spinta all’estero?
«Sì, ho lavorato per sei mesi nel laboratorio di Richard Youle a Bethesda, nel Maryland. In quegli anni il professor Youle aveva appena messo a punto una nuova tecnica di microscopia che permetteva di analizzare la fusione del reticolo mitocondriale nelle cellule in vivo. Studiando OPA1, una proteina coinvolta proprio in questo processo, ho imparato una nuova tecnica per poi applicarla nel mio progetto».
Quali sono le differenze tra Stati Uniti e Italia nel fare ricerca?
«Il laboratorio negli Stati Uniti mi aveva messo a disposizione scrivania, computer e un bancone tutto per me con un set personale di pipette. Potevo acquistare tutto ciò che mi serviva per la mia ricerca e avevo libero accesso a strumentazioni all’avanguardia. Una situazione ben diversa da quella cui ero abituata in Italia, dove bancone, pipette e scrivania sono spesso condivisi e dove, per scarsità di fondi e difficoltà burocratiche, non è possibile acquistare liberamente i materiali necessari per gli esperimenti».
Delle condizioni davvero ottimali per un ricercatore. Ci sono anche degli aspetti negativi?
«Forse l’unico aspetto negativo è la competizione molto alta. Un po’ di rivalità è stimolante e aiuta a dare il meglio, troppa genera ambienti malsani. Penso che la collaborazione tra scienziati sia fondamentale e permetta di raggiungere risultati che il singolo ricercatore da solo non potrà mai ottenere».
Hai un ricordo della tua vita professionale al quale sei particolarmente affezionata?
«Il giorno in cui, dopo una lunga e dura selezione, mi hanno comunicato che avevo vinto un progetto finanziato dal MIUR come coordinatore nazionale. Poter gestire in totale autonomia scientifica ed economica la mia ricerca è stato molto bello. E sono nate collaborazioni interessanti».
Da dove nasce questa tua forte passione per la scienza?
«Due figure sono state fonte di ispirazione per me. Margherita Hack, che aveva fatto della ricerca lo scopo principale della sua vita, e la mia responsabile durante il dottorato, una grande esperta in biochimica che riesce a far convivere perfettamente il suo lavoro di ricercatrice con la dedizione ai suoi tre figli. La considero una super-eroina».
E cos’è invece che ti motiva e ti spinge ad andare avanti tutti i giorni?
«La curiosità: di sapere, scoprire, capire. L’interesse per tutto quello che c’è intorno a me e per la vita».
A tuo avviso, cosa potrebbe fare la comunità scientifica per avvicinare la società alla scienza?
«Investire in comunicazione e divulgazione. Molti ricercatori hanno la capacità innata di spiegare in maniera semplice il loro lavoro, per altri è molto difficile. Far capire alle persone il processo scientifico che porta a nuove scoperte e permette lo sviluppo di nuovi farmaci è uno strumento molto efficace per vincere la diffidenza. Per esempio, quando si è trattato di vaccinare nostro figlio, mio marito aveva molti dubbi. Mi sono presa del tempo e gli ho spiegato in maniera molto semplice come funzionano virus e batteri e cosa può fare un vaccino. Gli ho fatto vedere come poteva verificare se una notizia era vera oppure no, come muoversi su Pubmed e che tipo di ricerche fare. Abbiamo studiato insieme e ora lui non ha nessun dubbio non soltanto sui vaccini, ma anche su ciò che fanno scienziati e ricercatori in questo settore».
Che cosa fai nel tempo libero?
«Leggo molto e scrivo. Amo la montagna, dove posso camminare, andare con le ciaspole e sciare. Mi piace molto anche viaggiare, scattare foto e, quando posso, fare delle gite in sella alla mia moto».
Qualche sogno o meta nel cassetto?
«Sciare su un ghiacciaio, vedere l’Africa e il Sud America».
Quando è stata l’ultima volta che ti sei commossa?
«Mi commuovo spesso, anche per piccole cose come vedere mio figlio e mio nipote giocare insieme al parco. A volte piango perché mi manca mio padre, morto a causa di un tumore nel 2012. È sempre presente nei miei ricordi e può capitare che pianga al solo ricordo di un bel momento passato assieme».
E la cosa che invece ti fa più paura?
«Che succeda qualcosa a mio figlio».