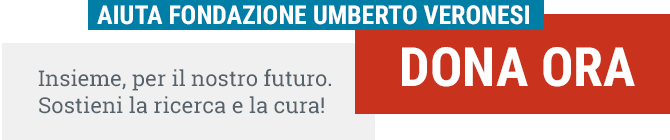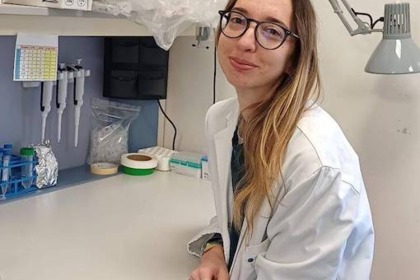Grazie all’autofagia, le cellule riciclano i composti dannosi. Ma i tumori possono sfruttare questo meccanismo per resistere ai chemioterapici: la ricerca di Giulia Petroni
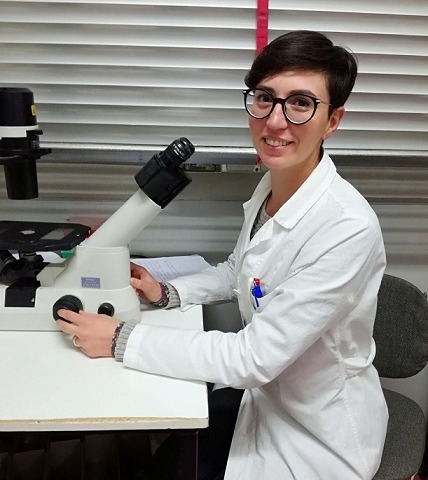
L’autofagia - scoperta premiata nel 2016 con il Nobel per la Medicina - è il processo con cui le cellule del nostro corpo «cannibalizzano» alcuni loro componenti. Questo meccanismo molecolare è fondamentale in situazioni di stress: permette l’approvvigionamento di energia riciclando componenti cellulari danneggiate, aiuta l’eliminazione di patogeni come virus o batteri intracellulari e degli scarti potenzialmente dannosi.
Sebbene l’autofagia sia un processo fisiologico per la cellula, disfunzioni in questo meccanismo sono legate allo sviluppo di molte malattie come il Parkinson, il diabete, il cancro e i disturbi del sistema immunitario. La resistenza ai farmaci chemioterapici, in particolare, rende l’autofagia un oggetto di studio importante per gli studi in oncologia.
Giulia Petroni svolge il proprio lavoro su questi temi negli Stati Uniti al Weill Cornell Medical College di New York, grazie al sostegno di una borsa di studio di Fondazione Umberto Veronesi.
Giulia, il tuo progetto vuole chiarire i legami tra autofagia e tumori. Ci racconti qualcosa in più?
«L’autofagia, attraverso il riciclo di componenti cellulari, permette alle cellule di sopravvivere in condizioni di stress o in assenza di nutrienti. Purtroppo questo processo svolge un ruolo chiave anche nello sviluppo neoplastico, consentendo alle cellule tumorali di sopravvivere in condizioni estreme e resistere all’azione dei farmaci».
È possibile agire sull’autofagia per colpire i tumori?
«Sembra di sì. Molti studi hanno dimostrato che l’utilizzo di alcuni farmaci capaci di modulare il processo autofagico, o modulatori dell’autofagia, consente di migliorare l’efficacia di terapie convenzionali e ridurre il rischio di ricomparsa della malattia. Per questo motivo, l’autofagia rappresenta un buon bersaglio terapeutico per il trattamento di molti tumori».
Su cosa si concentra, quindi, il tuo lavoro?
«Questo progetto vuole valutare l’efficacia terapeutica dei modulatori dell’autofagia mediante tecniche innovative e modelli animali di topo. Per esempio, sappiamo che l’autofagia svolge un ruolo fondamentale nel regolare le risposte immunitarie contro il tumore. I modelli animali permetteranno di valutare gli effetti dei modulatori sul sistema immunitario e sul microambiente tumorale, di valutare la risposta immunitaria e quella complessiva alla chemioterapia. Si tratta di passaggi necessari per applicare le conoscenze acquisite alla pratica clinica e sviluppare nuove strategie per combattere l’insorgenza di resistenza alla terapia».
Raccontaci di te: perché hai scelto di diventare ricercatrice?
«La scienza mi ha sempre affascinato sin da quando ero al liceo. Sono sempre stata indecisa se scegliere medicina, ma ho scelto biologia perché interessata alla ricerca pura. Ho sempre desiderato capire come sono fatte le cose e i meccanismi alla base di malattie importanti come i tumori».
Hai un momento da ricordare nella tua vita professionale?
«Il momento che vorrei incorniciare è sicuramente quello in cui ho letto che avevo vinto il bando di Fondazione Umberto Veronesi. Ho fortemente creduto nelle potenzialità di questo progetto ed erano tanti anni che desideravo fare un’esperienza all’estero per accrescere le mie conoscenze nel campo della ricerca immuno-oncologica e avere un’idea di come funziona la ricerca fuori dall’Italia. Purtroppo non ero mai riuscita a farlo: né negli anni di dottorato né negli anni a seguire. Fondazione Umberto Veronesi mi ha permesso di realizzare questo sogno che avevo nel cassetto da molti anni».
Come ti vedi fra dieci anni?
«Spero ancora ricercatrice. E spero che questo possa succedere nella mia città, Firenze, anche se ultimamente i finanziamenti alla ricerca italiana stanno sempre più diminuendo».
Cosa ti piace di più della ricerca?
«È un lavoro sempre in evoluzione, ogni giorno diverso. Non sempre ottieni quello che ti aspetti, ma a tutto c’è una spiegazione. La vera sfida è trovarla».
E cosa invece eviteresti volentieri?
«Il precariato, il dover rincorrere fondi e perdere molto tempo a scrivere bandi e progetti che spesso non vengono finanziati».
Cosa avresti fatto se non avessi fatto il ricercatore?
«La mia altra scelta è sempre stata medicina e un lavoro che mi piacerebbe fare è l’anatomopatologa».
Cosa ti spinge a fare ricerca ogni giorno?
«Ho sempre desiderato capire come sono fatte le cose e cosa c’è alla base di malattie importanti e devastanti come i tumori. Pensare che il mio lavoro possa essere utile per aiutare persone che necessitano di cure efficaci non ancora scoperte o messe a punto è quello che mi motiva ogni giorno».
Cosa fai nel tempo libero?
«Amo viaggiare, scoprire culture e popoli diversi. Ho il brevetto da sub e mi piace scoprire i fondali marini e i pesci dei luoghi in cui viaggio».
Hai famiglia?
«Ho i miei genitori, mio fratello che vive a Pesaro con sua moglie, il mio compagno Niccolò, anche lui ricercatore, un cane e un gatto».
Se un giorno tuo figlio ti dicesse che vuole fare il ricercatore, come reagiresti e cosa gli diresti?
«Sarei molto orgogliosa ma anche molto preoccupata per il suo futuro».
Sei felice della tua vita?
«Molto felice, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista degli affetti».
Raccontaci una pazzia che hai fatto.
«In uno dei miei viaggi, sono stata alle Hawaii sulla lava del vulcano Kilauea. Era nata come una battuta, ma poi ci siamo andati davvero. È stata un’emozione bellissima, in cui ti rendi conto di quanto possa essere devastante la forza della natura».
C’è una cosa che vorresti fare almeno una volta nella vita?
«Vorrei fare il bagno con gli squali balena».