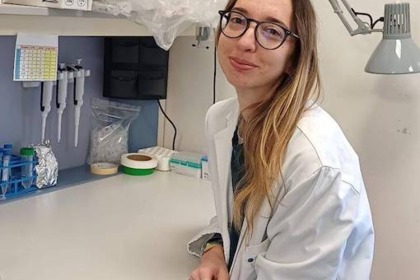Francesca Talpo studia la Corea di Huntington e i neuroni della base, coinvolti nell’esordio della malattia, per capire perché neuroni simili e mostrino una diversa sensibilità alla malattia
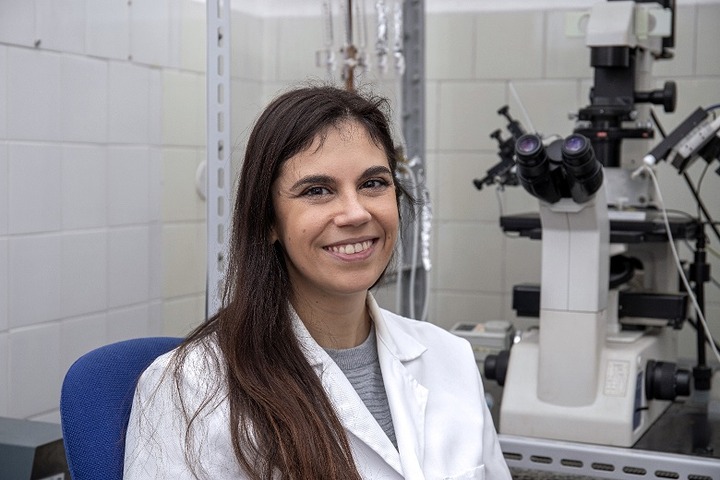
La malattia di Huntington è una condizione genetica neurodegenerativa caratterizzata da movimenti involontari a scatti (conosciuti col nome di «Corea», termine greco per danza) perdita di controllo delle funzioni corporee e demenza. Questa patologia è causata da un gene difettoso che interferisce nella produzione di una proteina, chiamata huntingtina, necessaria per il corretto funzionamento dei neuroni cerebrali. Sebbene le origini genetiche della patologia siano note dai primi anni Novanta, attualmente non esistono cure risolutive.
Nella corea di Huntington vengono colpiti tutti i neuroni, ma alcune aree del cervello risultano più vulnerabili alla malattia. E anche all’interno delle zone colpite, non tutti i neuroni presentano un uguale grado di sofferenza. Francesca Talpo, biotecnologa all’Università degli Studi di Pavia, sta studiando queste differenze per individuare nuovi meccanismi molecolari legati al decorso della malattia. Il suo progetto proseguirà per tutto il 2020 grazie al sostegno di una borsa di ricerca di Fondazione Umberto Veronesi.
Francesca, raccontaci qualcosa di più sulla patologia di Huntington al centro del tuo progetto.
«La Corea di Huntington è una malattia genetica neurodegenerativa che comporta nei pazienti degli importanti disturbi ipercinetici, comportamentali, psichiatrici e deterioramento cognitivo. Questi sintomi sono causati dalla perdita di neuroni in vaste aree del sistema nervoso centrale, in particolare in un’area del cervello che prende il nome di corpo striato. Ma il corpo striato stesso è costituito da quattro classi di neuroni con diverse funzioni: ciascuna di esse sembra essere compromessa in modi e misure differenti nel corso della malattia».
Qualche ipotesi sul perché?
«Attualmente no. Nel corso del mio progetto di ricerca, proverò a spiegare questa differente suscettibilità dei neuroni striatali usando un modello animale di topo che simula la malattia di Huntington. A questo scopo osserverò il funzionamento dei differenti neuroni striatali insieme al livello di espressione dei geni, effettuando un’analisi degli Rna presenti nelle singole cellule. In questo modo proverò a capire se esistono delle caratteristiche peculiari, in grado di identificare i neuroni compromessi o quelli preservati durante il decorso della malattia».
Quali sono le prospettive a lungo termine e le eventuali applicazioni alla salute umana?
«Per la malattia di Huntington al momento non esiste una cura e tutti i trattamenti attualmente in uso sono unicamente volti ad attenuare la sintomatologia di questa condizione. Comprendere meglio i meccanismi alla base della malattia di Huntington e individuare le caratteristiche specifiche dei neuroni colpiti potrà risultare utile per identificare nuovi bersagli farmacologici, così da permettere in futuro di sviluppare strategie terapeutiche mirate ed efficaci».
Sei mai stata in un laboratorio all’estero?
«Sì, ho lavorato per un anno come Post-doc a New Haven, negli Stati Uniti, presso la Medical School della Yale University. Questo laboratorio stava cercando un elettrofisiologo che si unisse al suo gruppo per svolgere in autonomia una serie di esperimenti relativi allo sviluppo del sistema nervoso. Ero interessata all'argomento, desideravo fornire un reale supporto portando le mie competenze e volevo confrontarmi con le dinamiche e le possibilità offerte da un'università di eccellenza americana. Così sono partita».
Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
«A livello lavorativo mi ha arricchito moltissimo, perché mi ha permesso di scoprire un modo diverso di approcciare e risolvere le domande scientifiche. Mi hanno soprattutto sorpreso le possibilità tecniche praticamente illimitate, sostenute attraverso ingenti finanziamenti a sussidio della ricerca. Tuttavia non ho apprezzato alcuni risvolti della mentalità di autodeterminazione che permea la cultura americana e mi è mancato l'approccio riflessivo alle problematiche scientifiche appreso in Italia. Inoltre, da un punto di vista personale, mi sono mancati i miei affetti e mio marito che era rimasto in Italia. Il mio progetto a lungo termine è sempre stato quello di tornare».
Ricordi il momento in cui hai scelto di diventare una ricercatrice?
«La scienza mi ha sempre appassionato e già alle elementari mi divertivo moltissimo a svolgere piccoli esperimenti per spiegare fenomeni curiosi. Mi sembrava che la scienza fosse un po’ magia. Crescendo, ho scoperto che dietro alla magia della scienza c’erano migliaia di ricercatori e moltissimo studio. Ho anche capito che, tra tutti i settori, la biologia e la medicina erano sicuramente i meno deterministici e quindi per me i più affascinanti. Quindi credo di avere sempre saputo di voler diventare una ricercatrice».
Hai un momento della tua vita professionale che vorresti incorniciare?
«Quando ho potuto stringere tra le mani il numero di Nature con in copertina una ricerca che mi vedeva tra gli autori».
Cosa ti piace di più della ricerca?
«Lo spirito di scoperta. Mi piace moltissimo la fase di pianificazione sperimentale, durante la quale si formulano delle ipotesi che devono poi essere verificate sperimentalmente. Trovo molto gratificante quando i risultati confermano le ipotesi iniziali, ma trovo anche estremamente stimolante quando invece le ipotesi iniziali vengono smentite e bisogna quindi formularne di nuove che spieghino le incongruenze. La scienza procede per piccoli passi e correzioni che raccontano una storia che fino al giorno prima non si conosceva. E io sono curiosa e amo le storie!».
Se ti dico scienza e ricerca, cosa ti viene in mente?
«Mi viene in mente Platone e la contrapposizione tra epistéme e dòxa, cioè la contrapposizione tra conoscenza scientifica verificata e opinione. In un periodo in cui purtroppo sembra emergere un sentimento antiscientifico collettivo e in cui le opinioni dei singoli vengono a volte poste sullo stesso piano dei risultati scientifici, credo sia ancora più importante ricordare la profonda differenza tra questi due processi conoscitivi della realtà».
In quali aspetti del lavoro, secondo te, può migliorare la comunità scientifica?
«Molti ricercatori tendono a gettarsi sullo studio dei temi che in un certo momento risultano più in voga e di moda. Questa scelta è in gran parte dalla necessità di raggiungere risultati concreti in breve tempo per pubblicare prima e meglio degli altri, e dalle dinamiche di finanziamento che tendono a prediligere il sostegno a progetti di carattere applicativo immediato a discapito della scienza di base. Ma in ambito biomedico capire i funzionamenti di base dell’organismo umano è altrettanto importante (o forse addirittura più) che sperimentare una molecola farmacologica».
Chi è Francesca nel tempo libero?
«Amo l’arte e soprattutto la danza. Ho iniziato a studiare danza classica quando avevo 6 anni e non ho più smesso: la trovo una forma di espressione molto più immediata e diretta delle parole, pur richiedendo a ballerini e pubblico un alto grado di attenzione e sensibilità perché il messaggio possa essere trasmesso».
Hai famiglia?
«Sì, sono sposata con Matteo e ho un figlio di un anno di nome Leonardo».
Se un giorno tuo figlio ti dicesse di voler fare il ricercatore, come reagiresti e cosa gli diresti?
«Se è ciò che desidera per il suo futuro, lo sosterrei nella sua scelta. Gli direi che ha scelto una strada difficile, ma meravigliosa. Gli direi che fare ricerca è come scalare una montagna: non gli nasconderei che la scalata per raggiungere la vetta sarà impervia e ricca di imprevisti, ma gli direi anche che i suoi sforzi saranno ripagati da un panorama spettacolare dalla cima».
Ricordi l’ultima volta in cui ti sei commossa?
«Quando per la prima volta mio figlio è salito con me sul palco e ho danzato con lui tra le braccia, in un balletto intitolato “la vita”. La biologia e la medicina sono le scienze della vita e la danza classica è la mia passione: condividere un momento che racchiudeva entrambi questi aspetti che amo con mio figlio di pochi mesi è stato molto emozionante».
La cosa che ti fa ridere a crepapelle.
«Il mio bambino felice che ride a squarciagola mentre gioca con il papà».
Prima di salutarci, c’è qualcosa che vorresti dire alle persone che scelgono di donare a sostegno della ricerca scientifica?
«Vorrei ringraziarli uno per uno, perché la ricerca è molto costosa e ha bisogno di sostegno e fiducia costanti per produrre risultati validi e che possano essere utili per migliorare la vita di tutti. Per favore, continuate a credere in noi e ad aiutarci nei nostri studi con le vostre donazioni. Noi vi promettiamo di svolgere il nostro lavoro con il massimo impegno ogni giorno per avvicinare sempre di più la possibilità di cura in caso di malattia».