Il pericolo del fanatismo
Anche la scienza si interroga sulla sperimentazione animale, a dimostrazione di quanto sia corretto non procedere in maniera dogmatica e precostituita
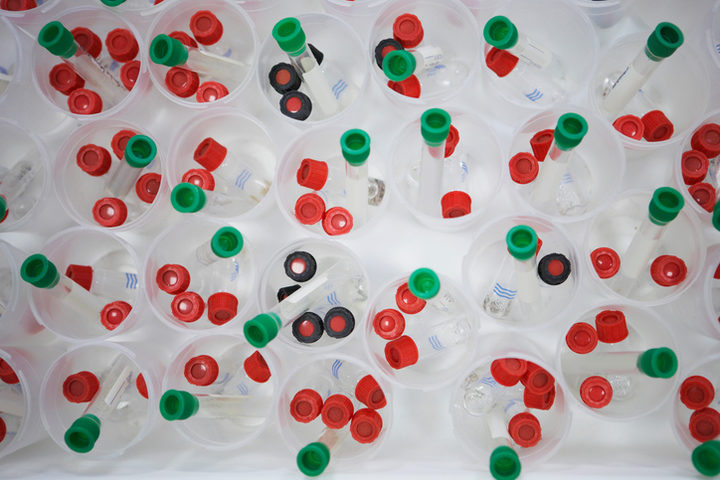
Nell'ultimo post abbiamo visto come non sia affatto vero che tutta la comunità scientifica appoggi indiscriminatamente la sperimentazione animale e men che meno abbia nei suoi confronti un atteggiamento dogmatico di accettazione passiva e totale. Questa accettazione, tipica di religioni e sette, è un procedimento che viaggia per assoluti e categorie, spesso senza la minima prova concreta e tangibile a sostegno. Gli esempi sono fin troppo banali: la religione (qualunque religione) ha la presunzione di poter distinguere il bene dal male come concetti immutabili e totali ("il Paradiso è il bene, l'Inferno è il male"), lo scientismo che, al contrario, non ammette nulla che non sia provato e tangibile; i fanatici politici, che non sono capaci di dialogare con altre parti perché non ammettono che la verità (o il "bene") possa anche parzialmente essere altrove.
Qualunque movimento proceda per assoluti e categorie sfocia nel fanatismo e, spesso e volentieri, questo sfocia nella violenza, verbale o fisica che sia. Vale per i fanatici dell'alimentazione che cercano adepti con tutti i mezzi, spesso e volentieri con informazioni menzognere e volutamente distorte, nel tentativo di convincerli che mangiare carne fa venire il cancro mentre bere succo di limone lo guarisce, vale per i fanatici del denaro che cercano di vendere acqua sporca per curare malattie purtroppo incurabili o braccialetti di plastica per riequilibrare il peso dell'anima, vale per i fanatici degli amplificatori a valvole (categoria a cui appartiene il sottoscritto) che non ammettono l'uso degli amplificatori a transistor perché il suono è troppo freddo e impersonale, vale per quelli che nella carbonara ci vuole il guanciale e non la pancetta. Ovviamente, vale anche per la sperimentazione animale, in cui gli attivisti anti-sperimentazione procedono per pura propaganda ("Ripetere ossessivamente una bugia fino a tramutarla in verità" e "Trovare un colpevole da crocifiggere", in questo caso, gli scienziati). Ognuno di loro si sente possessore del bene assoluto, della verità assoluta, etica e pratica. Questo procedimento non ammette sfumature e variazioni e, per questo, è completamente incompatibile con il metodo scientifico; una delle lezioni basilari che si imparano in un laboratorio è non innamorarsi di un'idea, per quanto affascinante e geniale e promettente essa sia.
Per questa ragione nell'ultimo post ho citato due articoli scientifici di critica alla sperimentazione animale. Perché ho scelto questi due? La ragione è molto semplice. Pur essendo entrambi lavori scientifici, scritti da scienziati, uno dei due muove critiche a mio avviso corrette e sensate, l'altro un po' meno. Citando entrambi, posso dimostrare che è vero che la scienza si interroga sulla sperimentazione animale; e fa bene a farlo, ma non sempre lo fa correttamente. Lascerò giudicare a voi quale dei due lavori sia quello che considero "buono" e quale sia quello "di parte", ma non credo sarà un giudizio troppo difficile da esprimere.
Cominciamo dal British Medical Journal, una rivista prestigiosa nell'ambito della medicina, che nel maggio 2014 pubblica l'articolo "Is animal research sufficiently evidence based to be a cornerstone of biomedical research?"("La sperimentazione animale è sufficientemente supportata da prove evidenti da poter essere una pietra angolare della ricerca biomedica?"). Il lavoro porta la firma di Pandora Pound e Michael Bracken, rispettivamente sociologa ed epidemiologo, quindi due figure professionali che, almeno stando alle loro carriere, non necessariamente hanno avuto contatto diretto con il mondo della sperimentazione animale, e questo è già di per sé un inizio così così. Il lavoro cerca di dimostrare principalmente una cosa: i risultati della sperimentazione animale non si dimostrano coerenti quando si passa all'uomo e quindi è inutile. Il salto logico è così lungo e profondo che il capitombolo è praticamente inevitabile. E infatti ci cascano. Innanzitutto, la sperimentazione animale non è unidirezionale. L'opinione pubblica è convinta che si usino animali unicamente per trovare nuove terapie da applicare sull'uomo, ma non è così. Una grandissima parte della sperimentazione animale, forse la più importante in termini di numero di animali utilizzati, fa esattamente il percorso inverso, cercando di riprodurre nell'animale i sintomi della malattia umana ("modellizzare" una malattia, si dice in gergo), per poterla studiare più da vicino. In questo senso, la sperimentazione animale ha trionfato in maniera assoluta. La sclerosi multipla, attualmente incurabile, è ora modellizzabile in tutti i suoi diversi aspetti nei roditori e, in minor parte, anche in altre specie, e i passi avanti nella ricerca di nuovi farmaci contro questa malattia devastante sono stati incredibilmente accelerati dalla presenza di questo modello. Negli anni 60 fu Arvid Carlsson ad accorgersi che il morbo di Parkinson era causato da un deficit della dopamina grazie alle iniezioni di reserpina nei ratti per modellizare la malattia: la dopamina divenne quindi terapia del Parkinson e Carlsson vinse il Nobel. Esiste un modello per la sindrome di Down e si procede a grandi passi per sviluppare un modello dell'autismo; grazie all'uso dell'ingegneria genetica è possibile diminuire moltissimo le differenze genetiche tra animali da sperimentazione ed essere umani, permettendo di avere animali "umanizzati" che possono prevedere meglio lo sviluppo della malattia. Inoltre, non dimentichiamoci del fatto che la stragrande maggioranza dei processi fisiologici dell'individuo sano, ossia come funziona il corpo umano senza malattie, sono stati scoperti dopo essere stati studiati in vari tipi di animali (il potenziale di membrana alla base dei processi che regolano la memoria, la riproduzione, la differenziazione cellulare, ...).
La domanda che di solito mi pongono a questo punto è "Ok, ma allora perché non esiste una cura per la sclerosi multipla?". Perché la scienza non fa miracoli. E dopo i vari Di Bella e Vannoni magari persino noi italiani potremmo averlo capito. Ai risultati buoni ci si arriva per gradi e dopo molti, moltissimi fallimenti i quali sono anch'essi dei risultati utili: dire che la SA è inutile perché non è stata in grado, finora, di trovare terapie efficaci contro la sclerosi multipla o "il cancro" (lo virgoletto perché di forme di cancro ne esistono moltissime, ma spesso la gente se lo scorda) è pura malafede. Ancora una volta, gli autori parlano di una grande delusione quando comparano il basso, secondo la loro opinione, numero di terapie efficaci sviluppate grazie alla SA con la quantità di fondi, pubblici e non, destinati a questo tipo di ricerca. Purtroppo dimenticano che chi gestisce tali fondi conosce perfettamente le dinamiche e i tempi della SA. In conclusione, le delusioni si misurano con le aspettative che si hanno: se ci si aspetta che la SA risolva malattie estremamente complesse come la sclerosi laterale amiotrofica o la corea di Huntington dopo appena 10 anni di ricerche, le delusioni saranno tanto inevitabili quanto devastanti; se invece ci si aspetta che la SA contribuisca ad accrescere la nostra conoscenza di tali malattie, allora tutto cambia. La SA non è né un successo né un fallimento ma uno strumento che, a seconda della prospettiva con cui lo si guardi, può sembrare più o meno utile.
Un errore che spesso ricorre nell'articolo di Pound e Bracken è citare il fallimento della SA nel modellizzare e trovare una cura corrispondente per l'ischemia cerebrale come un fallimento generale della SA. È vero, la SA non è riuscita ancora a trovare una cura per l'ischemia, anche se modelli animali di ischemia ne esistono; ma da qui a dire che per questo tutta la SA è inutile è, di nuovo, pura malafede. La dimostrazione del completo fallimento di queste argomentazioni arriva quando si confonde l'abbassamento del numero di animali utilizzati nelle case farmaceutiche con un abbassamento della fiducia nei risultati della SA. In parole povere, gli autori sono convinti che le industrie farmaceutiche utilizzino sempre meno animali perché non credono più alla loro utilità. Sbagliatissimo. Abbiamo visto in dettaglio ognuna delle 3R come principi etici che la SA si è auto-imposta e le applicazioni rigorose di questi principi, così come l'affiancamento di metodi in vitro e in silico (al computer) ai risultati in vivo, hanno contribuito a un sempre minor uso di animali: non è che non ci credono più, è che oggi, nel 2014, possiamo prescindere dall'uso di tanti animali.
Tra un'affermazione dell'ovvio ("specie animali e umane sono così complesse che anche una piccola differenza può essere importante". Ma và? E che ci stiamo a fare noi scienziati?) e bestialità scientifiche ("vista la grande quantità di sperimentazione animale utilizzata, i pochi successi riscontrati nell'uomo potrebbero essere frutto del caso". Ripeto, e che ci stiamo a fare noi scienziati?) o ancora tentativi di far andare in parallelo test pre-clinici e test clinici su pazienti umani (ossia, dare a pazienti umani sostanze senza ancora aver ben capito come funzionano) si arriva finalmente al grande punto, quello su cui ogni attivista anti-sperimentazione batterà sempre il chiodo: i soldi. O meglio, si fa SA perché fa fare soldi. Secondo gli autori, i governi, le autorità che gestiscono i fondi, gli scienziati, tutti hanno interessi finanziari nel proseguire la SA. Non spiegano in quale mondo sia plausibile che allevare un topo sia più economico che mantenere un incubatore di cellule, non giustificano l'affermazione. Semplicemente citano un altro articolo (questo) che non spiega assolutamente nulla al riguardo. Geniale.
L'altro articolo, pubblicato sulla rivista Public Library of Science One, si intitola "Ethical and scientific considerations regarding animal testing and research" ("Considerazioni etiche e scientifiche riguardo ricerca e test sugli animali"). È scritto da Hope Ferdowsian e Nancy Beck, entrambi membri del Physicians Comitee for Responsible Medicine ("Comitato medico di Medicina Responsabile"), una Ong che, stando a quanto si legge sull'articolo, "promuove un più alto standard nella ricerca con animali e nelle alternative ad essa riguardo ricerca scientifica, educazione e preparazione". Dato il nome della Ong e il titolo dell'articolo, è chiaro che qui l'impostazione è diversa. Qui si parla di etica. In realtà, l'articolo è diviso in due parti, in cui nella prima sono contenute una serie di considerazioni etiche riguardo l'uso di animali nella sperimentazione animale mentre nella seconda si tratta l'argomento del valore scientifico dei risultati a cui la sperimentazione animale ha portato. Riguardo l'etica c'è poco da commentare: è banale e scontato dire che il lavoro dello sperimentatore cammina nella zona grigia dell'etica e, come dicevamo nello scorso post, non esiste una risposta assolutamente corretta. Esattamente perché, come abbiamo già detto all'inizio, non esistono assoluti. Da quasi mezzo secolo esistono documenti fondamentali per la bioetica come il Codice di Norimberga e la Dichiarazione di Helsinki: giustamente, gli autori ricordano questo, così come la nascita delle 3R nel 1959, come pietre angolari per il connubio tra scienza ed etica. Varie nazioni nel mondo hanno adottato tutta una serie di leggi e codici per regolamentare l'uso di animali (non solo nella ricerca), cercando il più possibile di trovare un equilibrio tra vantaggi (economici, scientifici, sociali) e costi etici. Non sempre si è fatto un lavoro impeccabile: negli Stati Uniti, troppo spesso celebrati come patria della scienza, l'US Animal Welfare Act esclude uccelli e roditori (il 90% degli animali usati nella SA) e fanno bene gli autori a ricordarlo. Il tentativo degli autori di dimostrare che gli animali soffrono dolore e stress è nobile, forse un po' banale, ma certamente riuscito. Dimostrano senza ombra di dubbio che molti animali usati per la SA possono soffrire di ansia e depressione, condividono molti tratti genetici e anatomici con l'uomo, hanno coscienza di sé, eccetera. Probabilmente in maniera involontaria, gli autori giustificano ancora di più l'uso di animali per la ricerca: quale miglior modello utilizzare se non uno che condivide così tante caratteristiche con l'uomo?
Quando si passa alla seconda parte, quella riguardo l'analisi della bontà dei risultati della sperimentazione animale, gli autori incappano in qualche ingenuità di troppo, a mio avviso. A parte citare, anche loro, il (momentaneo) fallimento della sperimentazione animale riguardo l'ischemia cerebrale, citano anche un dossier del National Counsil of Research (NRC, il CNR statunitense) in cui si sottolinea la necessità di potenziare i metodi in vitro: banale e soprattutto, in questo momento, non sufficiente a giustificare un rimpiazzo totale degli animali. Gli autori stessi, però, si rendono conto che se da un lato è potenzialmente più semplice rimpiazzare gli animali nel campo della tossicologia (lo studio di nuovi farmaci, ad esempio), è molto più complesso farlo nella ricerca di base, ossia il modellizzare le malattie come prima abbiamo commentato, visto che "nessun metodo fornisce una conoscenza meccanicistica degli eventi molecolari", ossia nessuno di questi metodi è oggi in grado di spiegare in maniera soddisfacente i complessi meccanismi che caratterizzano uno stato patologico. Le loro conclusioni sono eccellenti: è necessario individuare i limiti dei metodi alternativi e riconoscerli non come barriere insormontabili ma come sfide da vincere nei prossimi anni. Quale critica è la più corretta, quindi?
Francesco Mannara








